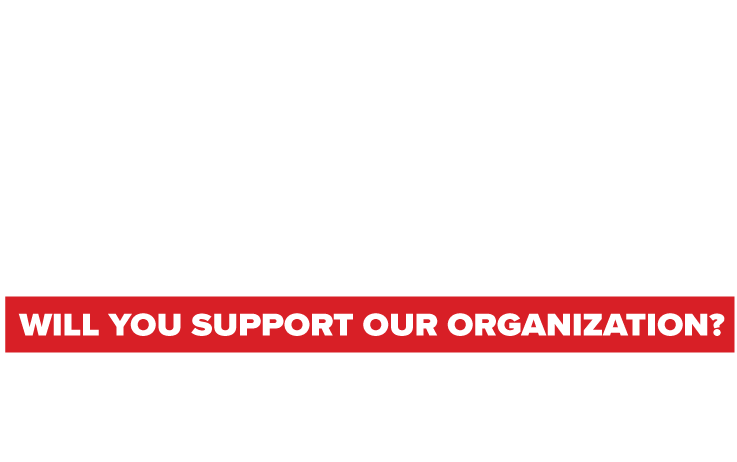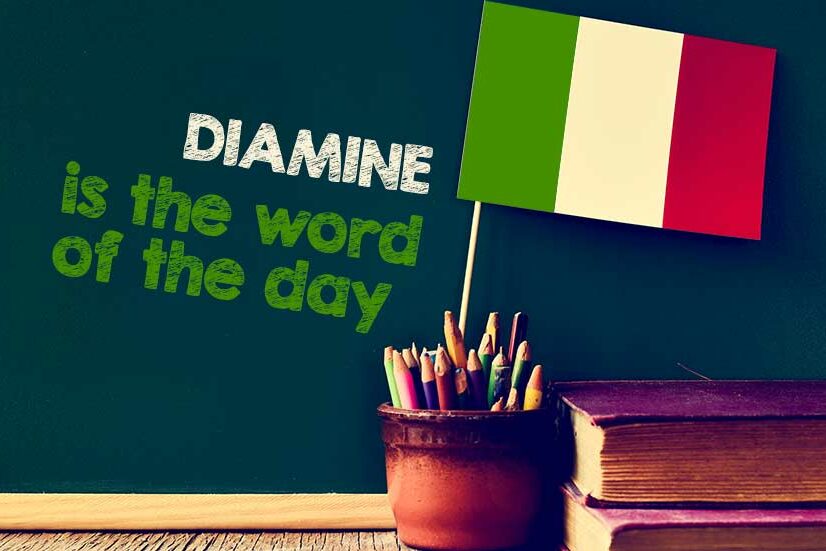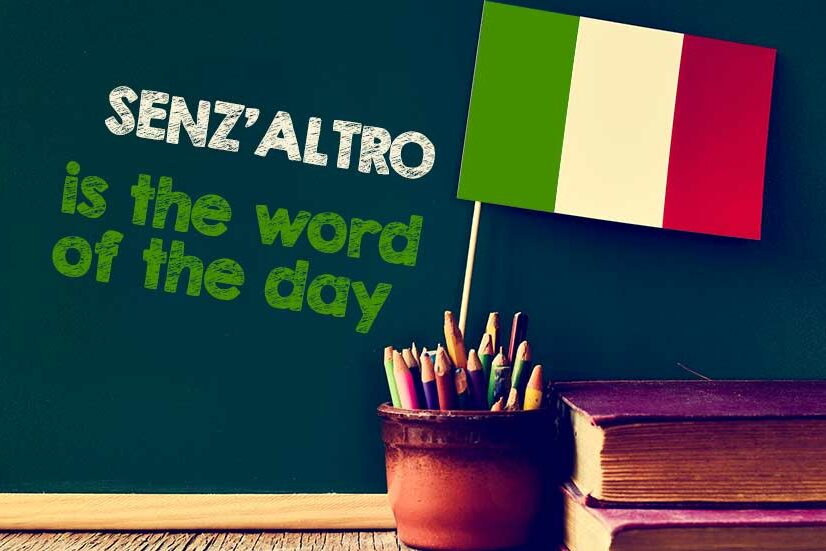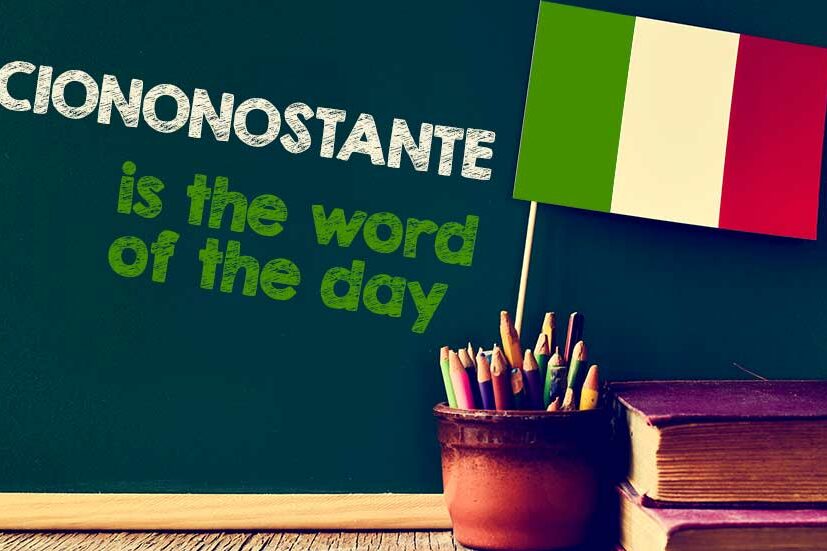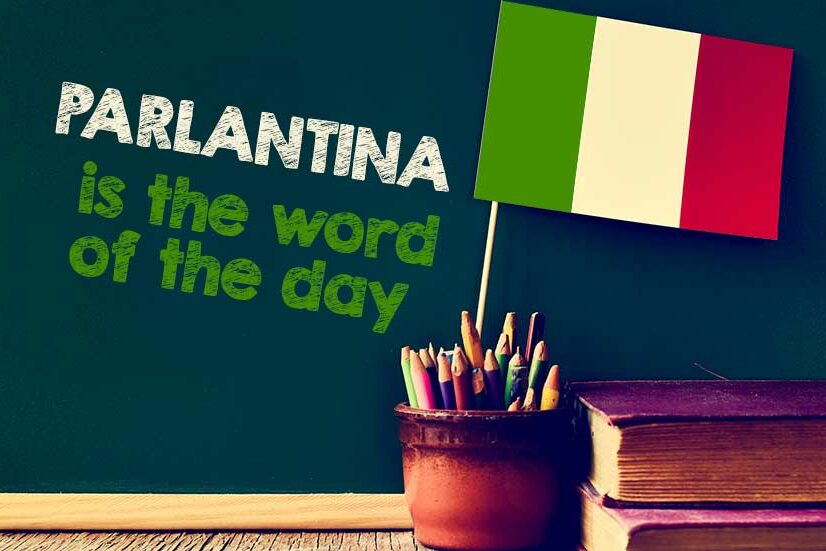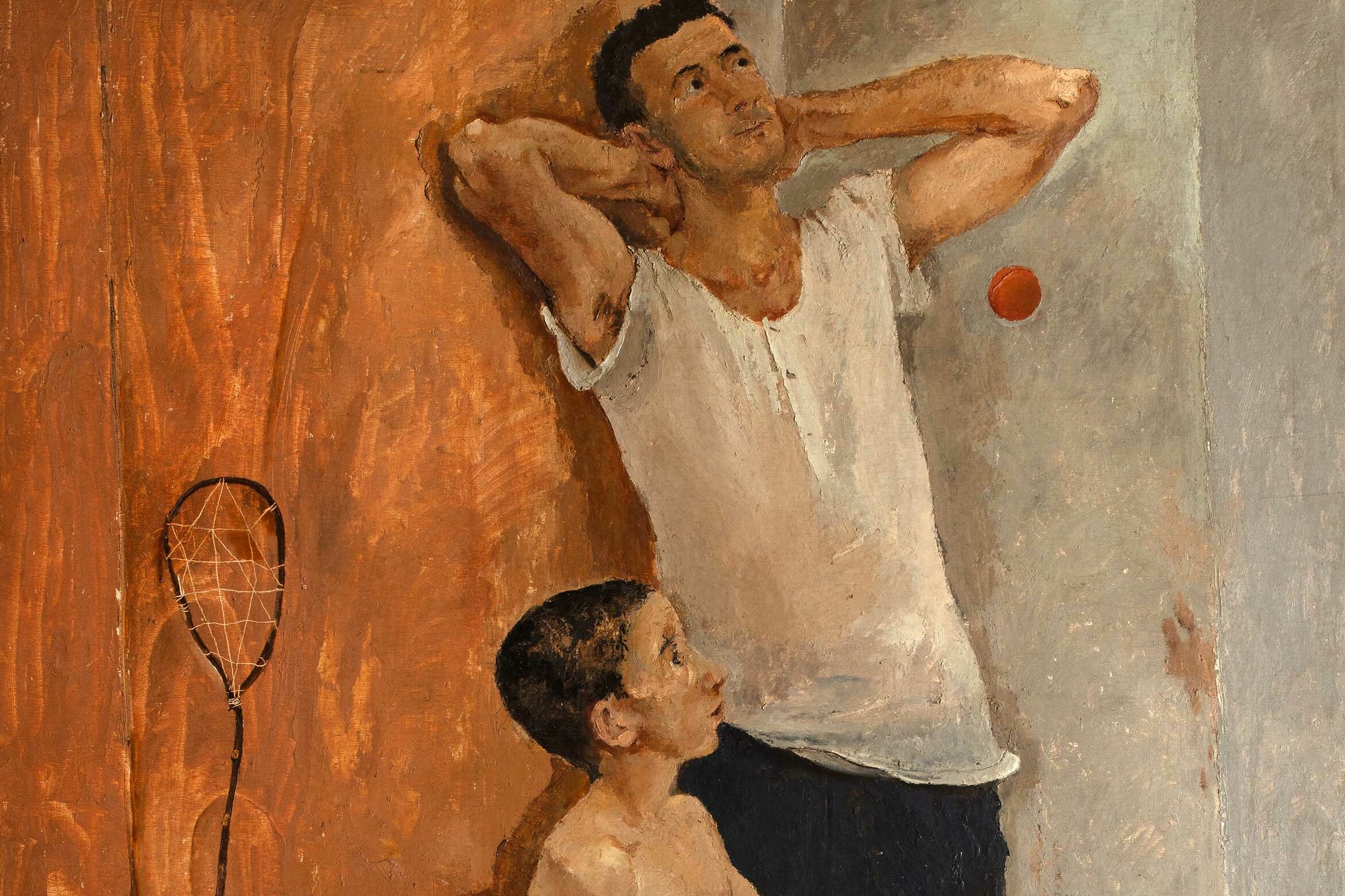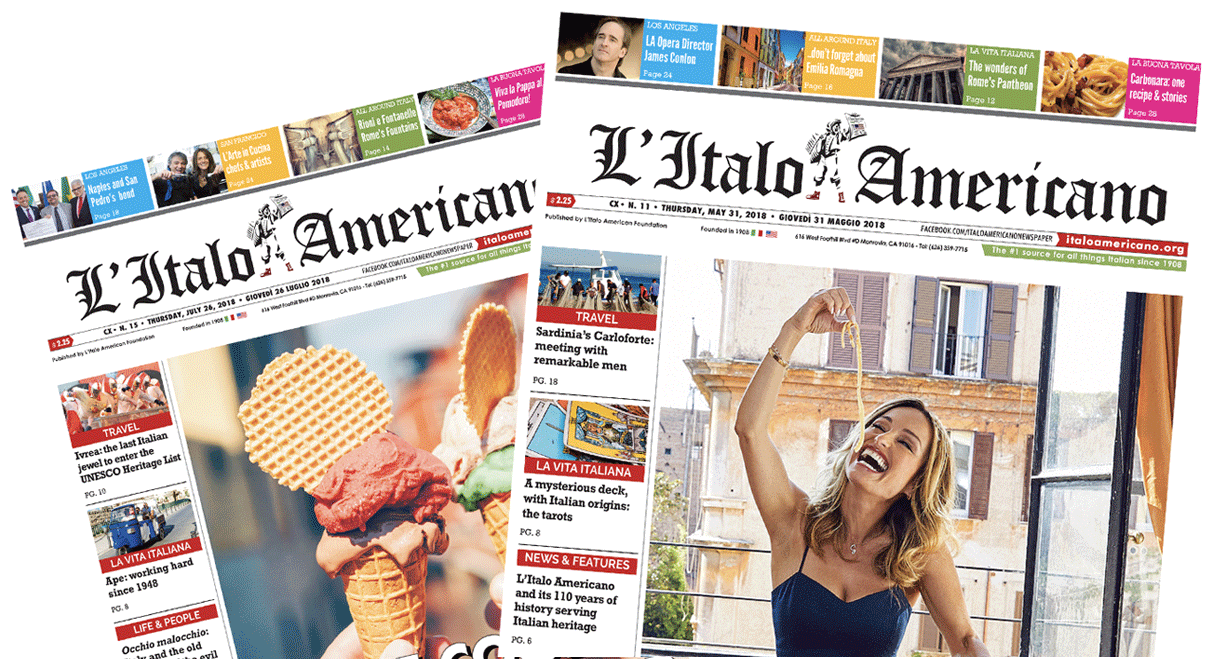Vogliamo essere sempre come gli altri quando andiamo a scuola. Però diventa difficile quando già dal momento in cui apri il sacchetto con il tuo pranzo è radicalmente diverso da quello degli altri.
Noi figli di italiani vedevamo i triangoli precisi dei sandwich dei nostri compagni australiani che sembravano usciti dallo studio di un architetto, magari con la crosticina tagliata lasciando soltanto il bianco in contrasto con il prosciutto cotto, pomodori e foglia di lattuga del suo ripieno. I nostri panini, o fette massicce di pane casareccio, magari con il ripieno degli avanzi della parmigiana del giorno prima, oppure con la frittata di cipolle, il cui profumo veniva percepito da tutti quelli intorno a te, accompagnati da una fetta della torta di mela di mamma, sembravano arrivati da un altro pianeta.
Sono tra i ricordi condivisi con i miei coetanei in Australia e non ho dubbi che sono simili alle esperienze dei nostri amici e parenti in altri paesi di forte emigrazione italiana. Ma questi ricordi non sono che una parte di un lungo viaggio verso una scoperta che durante gli anni di scuola non eravamo in grado di capire.
Già a scuola sentivamo la domanda “and how do you spell that?” (“E come si scrive?”) che inevitabilmente seguiva la nostra risposta di come ci chiamavamo. Per un nome come Mario Rossi era abbastanza facile, ma già il mio creava difficoltà, sia come ortografia che come pronuncia per gli anglofoni. Per noi italiani era difficile, figuriamoci per i greci con cognomi di dieci e più lettere. Questa domanda ci segue ancora oggi in quasi tutte le telefonate a uffici per qualche pratica di qualsiasi genere.
Ovviamente il lunedì mattina, come in tutte le scuole, le prime domande erano su cosa avevamo fatto durante il weekend, visto che in Australia non si va a scuola di sabato. Per gli australiani il weekend era football australiano e possibilmente un’uscita al cinema a un’età molto più precoce di noi figli di immigrati. Invece noi parlavamo della cena di sabato sera con questo o quell’altro compare, oppure di essere andati la domenica da una zia, o un’uscita, sempre di famiglia, alla festa di qualche santo o Madonna per adempiere i nostri doveri religiosi. Senza scordare i weekend dedicati al vino, o al maiale dove c’era l’obbligo per tutti di stare a casa per aiutare.
Quando eravamo adolescenti noi maschi di origine italiana avevamo una libertà che non esisteva per le nostre sorelle e cugine. Potevamo uscire per raggiungere i nostri amici e magari avere i nostri primi flirt. Per le ragazze italiane le uscite erano strettamente controllate e in molti casi accompagnate da almeno un adulto. Poi, quando cominciavano le prime storie d’amore di queste ragazze il probabile fidanzato era esaminato con occhi impietosi, spesso sospettosi riguardo a ragazzi italiani di altre regioni, o con espressioni di orrore per tanti genitori, se erano ragazzi di altre nazionalità.
Sembrano quasi ridicoli oggi, questi ricordi di vecchia emigrazione, ma erano la nostra realtà.
Come gli sguardi sospetti dei passeggeri australiani sui mezzi pubblici durante un’uscita con mamma in centro. Erano sguardi che facevamo finta di non vedere, ma a volte lo sguardo diventa “l’ordine” di parlare in inglese visto che eravamo in Australia. Queste richieste, più o meno brusche, non sono mai sparite del tutto e ancora oggi, che abito in Italia, di tanto in tanto sulle pagine dei giornali australiani vedo articoli di incidenti sui pullman o i tram australiani di passeggeri che si sentono offesi nel sentire parlare altre lingue vicino a loro.
Ogni emigrato italiano ha storie del genere e ognuno di noi ha reagito in modo diverso. C’è chi ha anglicizzato il nome per evitare i problemi, c’è chi ha avuto problemi a scuola e nella vita in generale perché la sua risposta era violenta e ogni variazione tra queste due scelte. Poi, come in tutte le questioni della vita, man mano che cresciamo e impariamo le lezioni che la vita ci dà ogni giorno, ci rendiamo conto che questi comportamenti hanno un legame in comune.
Sono tutte esperienze legate alla paura più comune di tutte, la paura dello sconosciuto.
In tutti i casi, noi emigrati e figli d’emigrati, eravamo e siamo tutt’ora lo sconosciuto per chi ha vissuto in un Paese con poca esperienza delle diversità delle altre culture. Eravamo la prova che fuori della realtà australiana esistevano idee e comportamenti diversi. Già per loro le differenze tra inglesi, gallesi, irlandesi e scozzesi erano difficili da capire, figuriamoci con l’arrivo di italiani, greci e tutti gli altri immigrati da un’Europa ancora devastata dalla Seconda Guerra Mondiale. Ma queste ondate di lingue e tradizioni nuove per il Paese non sono mai sparite del tutto e ogni conflitto importante ha portato nuovi immigrati, dal Vietnam dopo la caduta di Saigon, dal Sud America, dai Paesi sotto le dittature militari e dagli altri conflitti fino alle guerre e le stragi del Medio Oriente di questi anni.
Ogni immigrato e profugo che arriva alimenta quella paura dell’ignoto che non è mai sparita del tutto. Ora questa paura dell’ignoto che viene con i volti e le tradizioni nuove ha colpito l’Europa, soprattutto in quei Paesi che non avevano mai avuto l’esperienza di far integrare grandi numeri di nuovi residenti con la loro varietà di religioni, sette, tradizioni e abitudini culinarie.
Ogni giorno mentre giro in piazza, guardo i notiziari, leggo i giornali e seguo dibattiti televisivi sento frasi e commenti che sentii per la prima volta a scuola e che mi hanno accompagnato per tutta la vita. Sono la prova della verità più profonda che pochi vogliono riconoscere: in fondo siamo tutti uguali e abbiamo gli stessi bisogni e le stesse paure.
L’australiano del 1960 che disprezzava il figlio di un soldato italiano che aveva combattuto quindici anni prima e che ora abitava nel suo Paese non è diverso dall’italiano di oggi che vede arrivare gente da Paesi dove soldati italiani hanno combattuto in nome della civiltà occidentale. Paesi europei che una volta erano campi di battaglia tra cattolici e protestanti con milioni di morti ora si trovano con fedeli di una nuova religione.
Sono paure e reazioni da capire e da superare, come è già accaduto volta dopo volta in altri paesi. Sono la prova che viviamo sempre nella Storia e che stiamo scrivendo i libri di Storia che i pronipoti studieranno a scuola tra qualche decennio.
Abbiamo superato difficoltà peggiori. Dimostriamo che anche questa volta siamo in grado di superare questo periodo nel migliore dei modi.