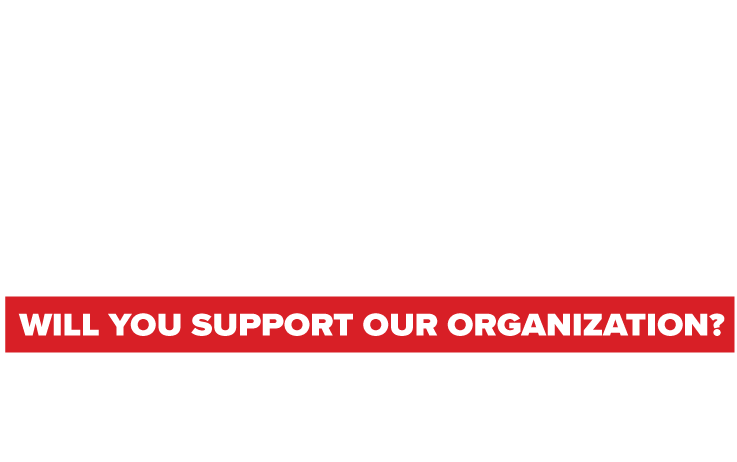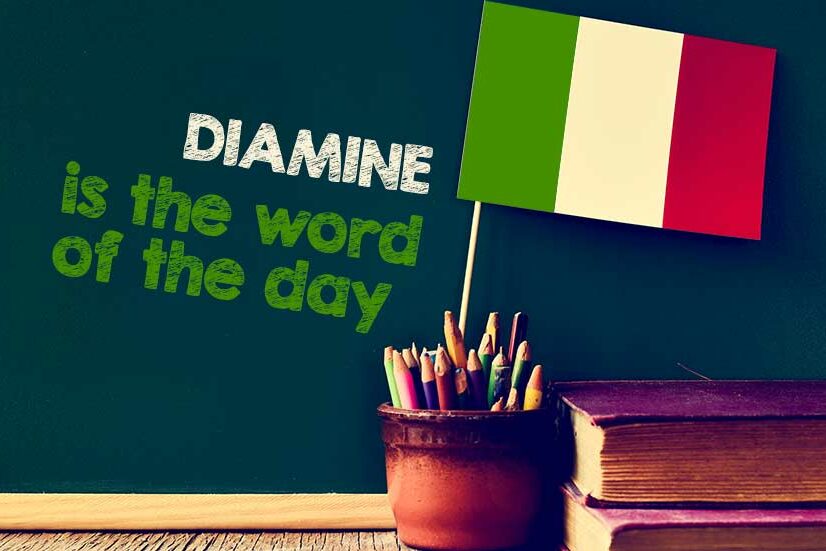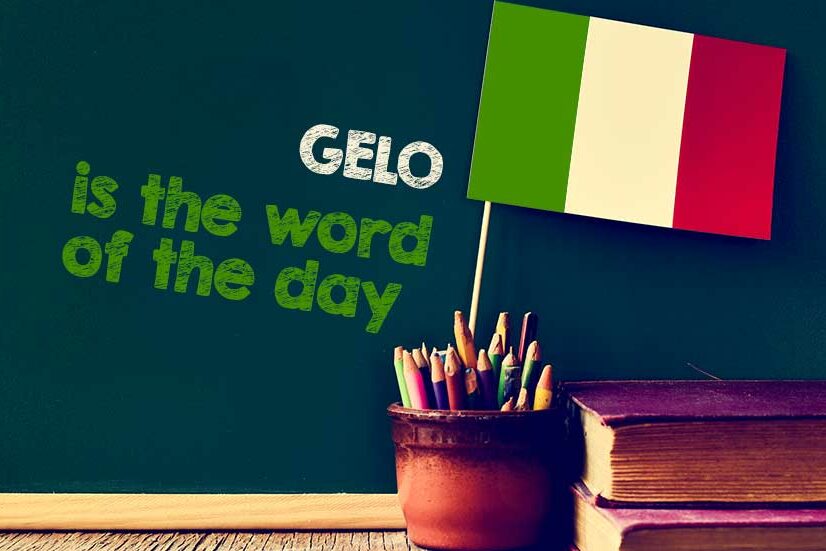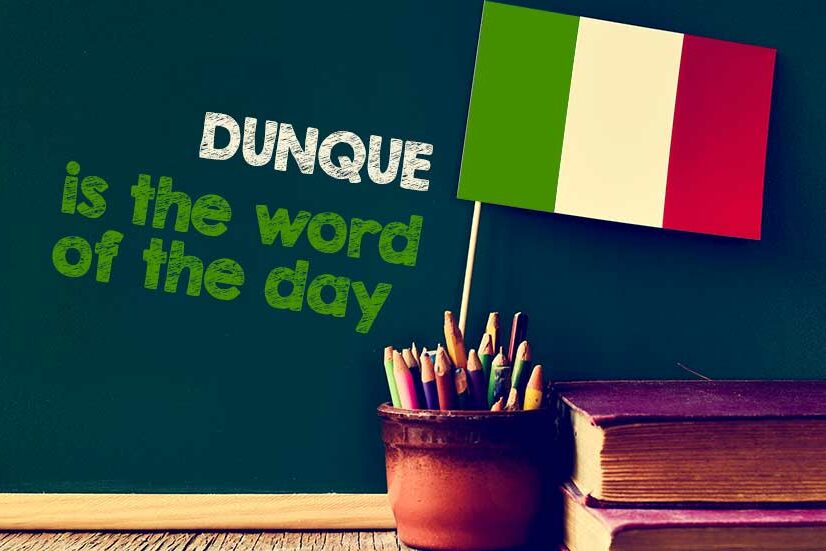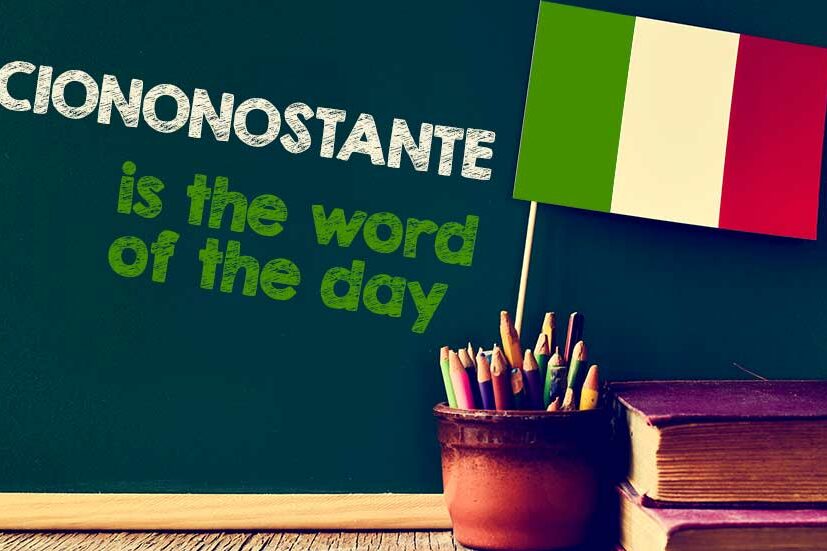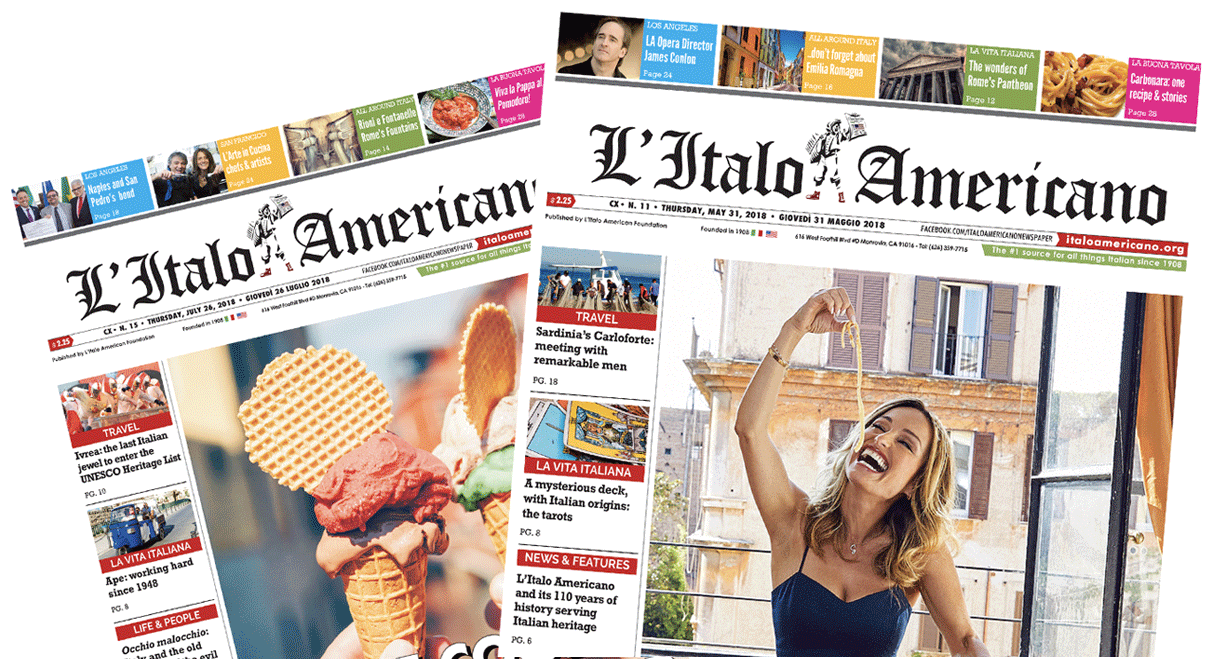In provincia d’Agrigento, nell’incantevole arcipelago delle Isole Pelagie, Lampedusa ha la particolarità di trovarsi in pieno Mar Mediterraneo, più vicina alla costa africana che a quella siciliana. Le sue acque cristalline, i faraglioni, le spiagge, le grotte e la fauna ittica attirano d’estate turisti e sub alla scoperta delle sue punte e delle sue cale.
La sua posizione geografica, ai confini dell’Italia meridionale, ha fatto sì che l’isola fosse fin dall’antichità luogo di sosta per Fenici, Greci, Romani e Arabi. In particolare i Romani la sfruttarono per impiantarvi uno stabilimento per la lavorazione del pesce e la produzione del garum, una ricercatissima salsa di pesce, mentre gli Arabi la utilizzarono come approdo per le loro scorribande piratesche.
Successivamente abitata da coloni francesi, inglesi e russi, i Lampedusani divennero sudditi del Regno d’Italia nel 1961.
La bellezza di Lampedusa è purtroppo oggi messa in secondo in piano dal grave problema politico e sociale del gran numero di migranti provenienti dall’Africa che costantemente l’isola si trova a soccorrere e ad accogliere. La sua posizione strategica come crocevia di commerci e la sua vicinanza alle coste africane, che in passato l’hanno resa luogo di passaggio, la rendono oggi meta primaria per milioni di migranti e rifugiati che, in fuga dalla povertà, dalla guerra e dalla violenza, si aggrappano ad un viaggio di speranza intrapreso su barconi piccoli e affollati, in condizioni pessime e senza alcuna garanzia di raggiungere la destinazione di salvezza.
Completamente circondata dal mare, quella stessa fonte che gli conferisce bellezza e sostentamento per turismo e pesca, l’isola diventa paradossalmente ciò che la estranea, la aliena e la allontana dal resto del mondo lasciandola sola ed in difficoltà nell’affrontare un problema che in realtà riguarda tutta l’Italia e l’intera Europa.
Accade così che, quando si ascolta il telegiornale e si assiste alle immagini di barconi in mare e di gente disperata (uomini, donne e bambini), si pensa ad una realtà lontana. Lampedusa appare nell’immaginario comune e collettivo come un luogo ai confini del mondo, se non fosse che quella stessa isola è italiana e i suoi abitanti parlano il dialetto siciliano.
Lo straordinario documentario “Fuocoammare” realizzato dal regista Gianfranco Rosi, opera italiana vincitrice dell’Orso d’oro all’ultima edizione del Festival del cinema di Berlino, ultimamente ha finalmente fatto parlare di Lampedusa in senso positivo grazie al premio ricevuto con grande orgoglio da parte dell’isola (e dei suoi abitanti) che ha raggiunto una messa a fuoco adeguata e che, da grande abbandonata quale normalmente si sente, è stata giustamente messa in primo piano agli occhi del mondo nella sua profonda contraddizione caratterizzata dall’ineffabile bellezza della sua natura incontaminata tra cielo e mare e la costante e tragica realtà dei migranti.
Rosi ha trascorso un anno sull’isola per girare un documentario celebrativo nei confronti di tutti gli aiuti umanitari e i soccorsi ai migranti da parte della Marina Militare italiana e del medico dell’isola Pietro Bartolo, che da trent’anni assiste ad ogni singolo sbarco, e profondamento accusatore verso l’indifferenza di quella umanità italiana, europea e mondiale che ancora non assume una posizione comune e solidale per far fronte ad un problema che riguarda tutti.
E così, in “Fuocoammare”, mentre i barconi continuano ad essere avvistati e masse di migranti morti, disidratati e mal nutriti continuano ad arrivare, la vita procede sull’isola come se nulla fosse.
Zia Maria si dedica alle faccende domestiche ascoltando le notizie alla radio che sembrano un eco lontano; un pescatore scende per pescare ricci e patelle in mare; il dj Pippo siede fisso di fronte alla radio ricevendo le dediche degli isolani. La passiva quotidianità e la tragica realtà sembrano restare mondi paralleli che non si incontrano mai.
Lo stesso atteggiamento di separazione e distacco si riscontra in Samuele, protagonista del documentario, ragazzo alle soglie dell’adolescenza che vive la sua isola in modo spensierato: va a scuola, gioca con la sua fionda e ha il mal di mare che cerca di superare navigando. Samuele ha l’occhio pigro che rappresenta metaforicamente quell’umanità che non vuole vedere o ignora una realtà difficile. Tuttavia il ragazzo è giovane, vuole guarire il suo occhio pigro, pertanto lo cura e si sforza di guardare meglio.
Il “fuoco in mare” da cui prende il titolo il documentario risale ad un episodio che la nonna racconta al piccolo Samuele: durante la Seconda guerra mondiale la nave militare “La Maddalena”, che navigava al largo delle coste di Lampedusa, fu affondata dai bombardamenti. Dalla nave divampò un incendio, un fuoco che dal mare illuminò l’isola a tal punto che i suoi abitanti andavano gridando: “Chi fuoco a mmari ca ce stasira”.
Il “fuoco in mare” di oggi al largo di Lampedusa è ben altro. Se si è uomini e se si ha coscienza, non lo si può ignorare o trascurare. I Lampedusani continuano ad agire a testa alta, orgogliosi del loro operato. Il premio cinematografico dell’Orso d’oro li riguarda in prima persona ed insegna che forse tutti dovremmo sforzarci di guardare meglio.