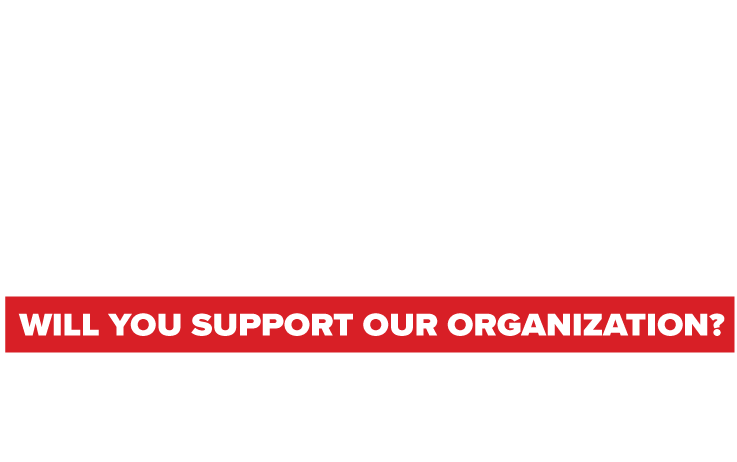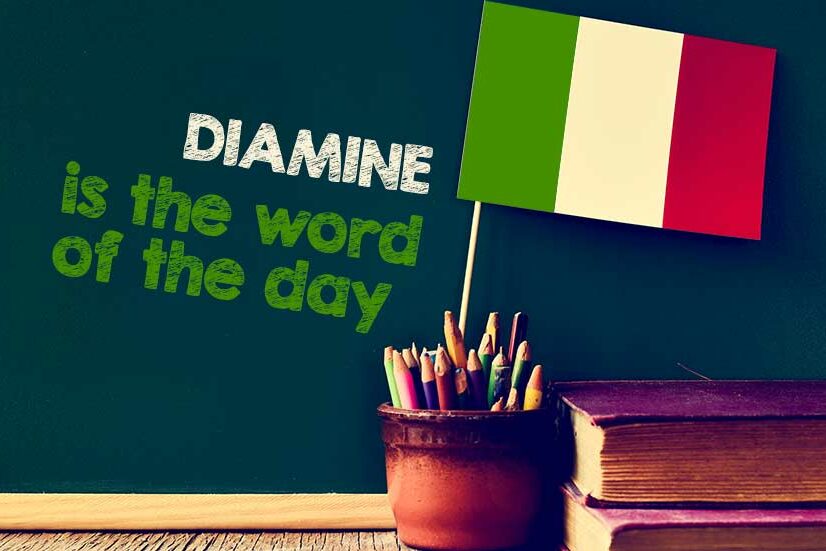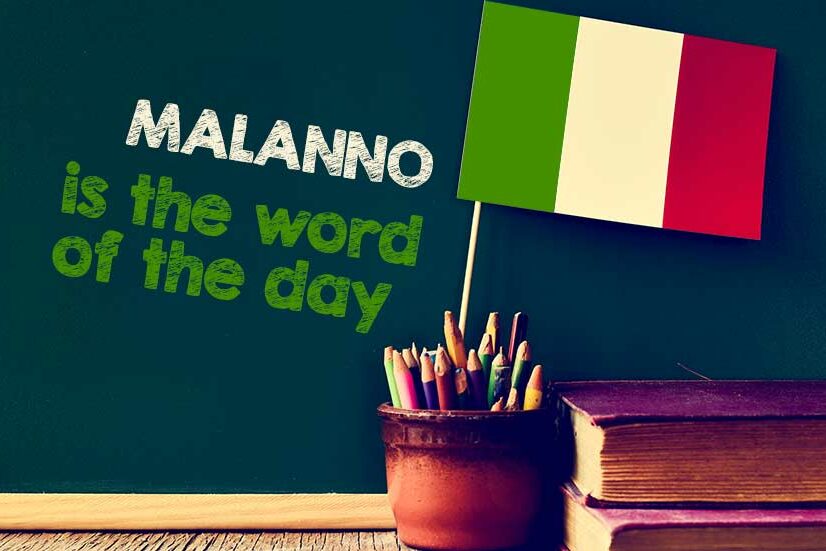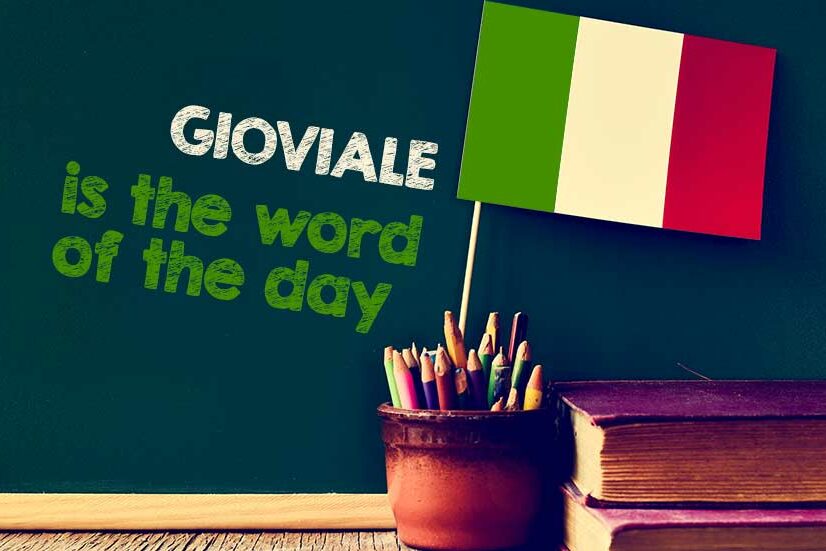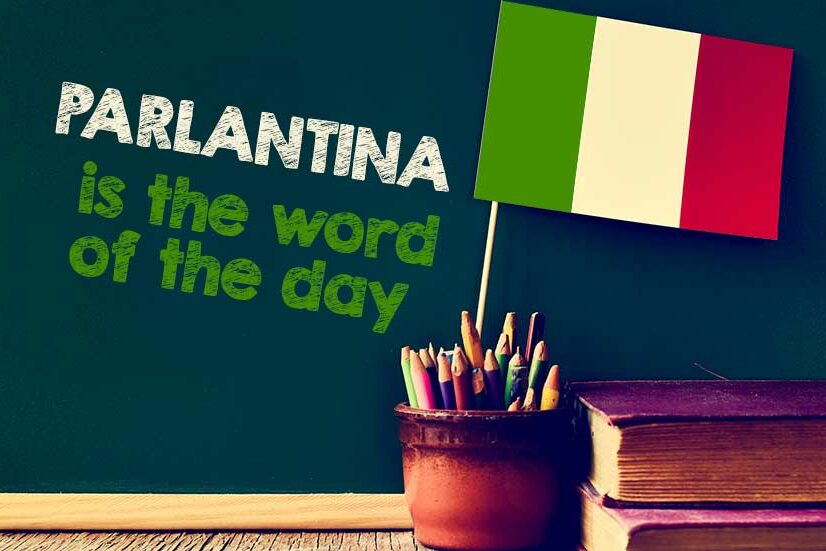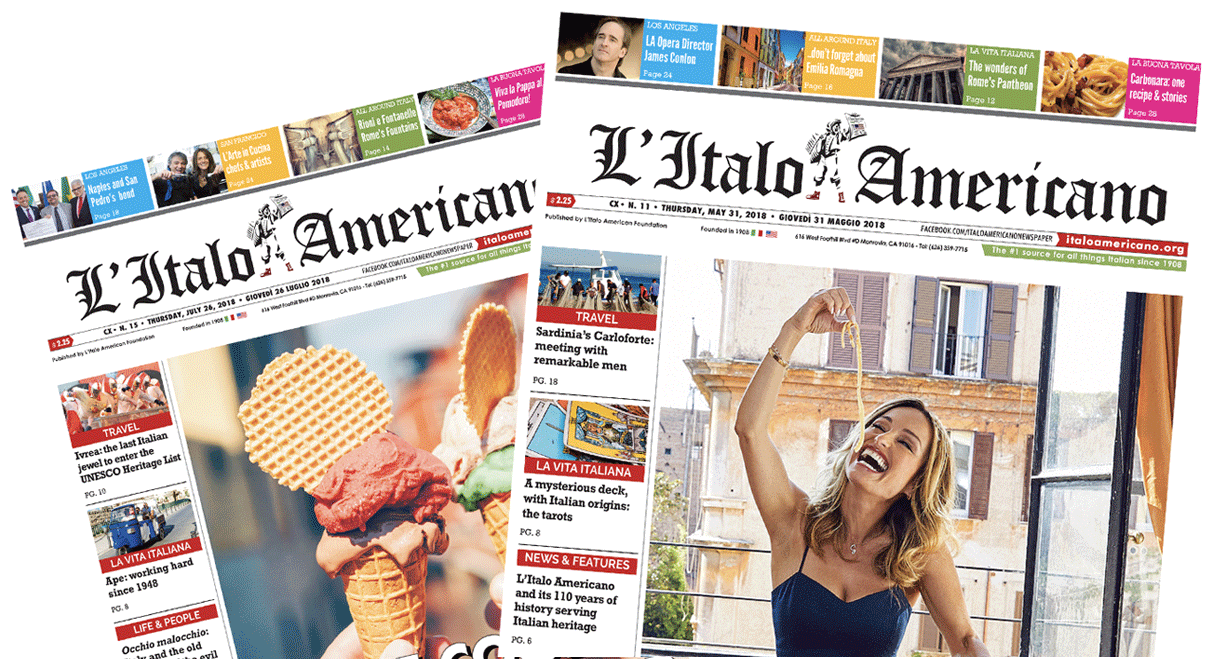Di tanto in tanto qualcuno fa il discorso sulle origini vere degli spaghetti. È uno di quei temi vicini ai nostri cuori, ma nasconde una verità che pochi conoscono per bene. Il mercato mondiale non esiste solo da poco tempo e ha avuto nel tempo capacità tali di “alterare” le distanze, di cui oggi possiamo solo sorprenderci.
Nel 2004 ricercatori dell’Università di Cincinnati hanno annunciato una scoperta sorprendente a Pompei che ha messo in ombra il predetto dibattito sul nostro piatto nazionale.
Nel corso delle analisi sui prodotti trovati all’interno di una macelleria dell’epoca romana, hanno scoperto tracce di carne di giraffa e, scoperta ancora più inattesa, di spezie esotiche provenienti dall’Indonesia.
Molti storici ritengono che gli scontri continui tra i Romani e i Parti avessero origini negli scambi commerciali lungo la via della seta. Infatti, sappiamo da tempo che i Romani usassero la seta, un prodotto esclusivamente cinese all’epoca, ma le spezie indonesiane dimostrano chiaramente che la rete commerciale del periodo antico era molto più estesa della semplice Cina che allora non era ancora un impero.
Molti di noi pensano a un mondo antico limitato geograficamente ma scordano che Alessandro Magno andò in India e, nell’Anabasi, Senofonte raccontò la storia di soldati greci persi nell’impero persiano nel quarto secolo avanti Cristo. Già da questi due fatti avremmo dovuto capire che gli scambi commerciali e intellettuali tra continenti risale a periodi molto più antichi di quel che pensiamo.
La Storia dimostra che i nostri periodi importanti spesso coincidono con i nuovi incontri tra civiltà e sempre con conseguenze importanti per entrambi questi antichi poteri.
Studiamo il periodo delle Crociate per conoscere le avventure e sventure dei crociati cristiani e magari i gesti cavallereschi di Saladino, ma non notiamo che quel periodo ha avuto effetti profondi sull’economia e la cultura di quel che molti considerano il Vecchio Continente.
Sarebbe facile parlare dell’introduzione di prodotti nuovi per l’alimentazione europea.
Iniziamo dallo zucchero che prende il nome dalla parole araba súkkar, come anche le albicocche e altri frutti, per arrivare alle nuove spezie o alle metodologie culinarie sconosciute a quelle zone dell’Europa che non avevano avuto un’occupazione araba diretta come invece ebbero la Sicilia e la Penisola Iberica.
Però, per quanto amiamo la cucina, gli effetti più importanti di questo periodo furono nei vari campi culturali e scientifici.
Chiunque abbia studiato il Rinascimento italiano sa che una delle ispirazioni dell’Arte nuova era la scoperta di vecchie opere d’epoca antica, sia romana che greca. Il rispetto degli arabi per questi grandi scrittori era più grande di quello degli stessi europei che li avevano disprezzati e avevano cercato di annullare come rappresentanti pagani di un passato incompatibile con i dettami del Cristianesimo. Se sappiamo molto del nostro passato classico è proprio grazie a queste scoperte inattese fatte dai crociati.
L’altro campo fondamentale che beneficiò dalle scoperte nel Regno franco fu ovviamente quello scientifico. Una prova interessante si trova nel processo dei Templari dove uno dei capi d’accusa contro i cavalieri erano i loro rapporti amichevoli con gli arabi. Eppure, tra questi rapporti c’erano quelli, importantissimi, con medici arabi per il semplice fatto che i dottori mediorientali avevano i mezzi e la consapevolezza di trattare e guarire ferite e malattie che per i medici europei erano ancora fatali.
Chissà quanti di quelli che dicono che gli arabi hanno dato pochi contributi alla nostra cultura e scienza sanno che i numeri che utilizziamo oggigiorno sono di origine araba e che furono introdotti in Europa dal matematico italiano Fibonacci nel Novecento del primo millennio cristiano. L’introduzione di questi numeri, come anche l’algebra, un’altra parola araba, e altri concetti importanti della matematica hanno dato un contributo essenziale allo sviluppo delle scienze matematiche che hanno creato il nostro mondo moderno.
Altro esempio. Le nostre industrie moderne della porcellana non hanno origine in Europa, bensì in Cina dove per secoli le famiglie aristocratiche europee commissionavano i loro servizi di piatti e tazze. Nel corso del sedicesimo e diciassettesimo secolo milioni di pezzi di porcellana, a un costo enorme per il Vecchio Continente, venivano importati ogni anno dalla potenza cinese. Tanti erano i soldi spesi per questi acquisti che in Olanda, Inghilterra, Italia ed altri Paesi europei imprenditori locali iniziarono a produrre i servizi e i prodotti che ora conosciamo come parte del nostro patrimonio artistico. Un patrimonio che sarebbe stato impossibile senza questo commercio antico.
Quando ci si lamenta dei cinesi e degli altri Paesi asiatici che ora copiano i nostri prodotti ricordiamoci che siamo stati proprio noi, per primi, a copiare i loro prodotti e non solo la ceramica, ma anche la seta che abbiamo importato in Europa per creare una nuova industria importante per noi.
Naturalmente un altro periodo importantissimo per l’introduzione di prodotti dall’estero fu quello che seguì la scoperta delle Americhe. Si potrebbero riempire pagine dei prodotti introdotti dal Nuovo Mondo che hanno cambiato per sempre la cucina e le industrie europee. Basterebbe chiedere che cucina avremmo oggi senza il mais, la patata e il pomodoro per capire l’impatto enorme dell’antico commercio mondiale sul nostro stile di vita.
Lo scrittore napoletano De Crescenzo: il pomodoro ebbe l’impatto della Rivoluzione francese nell’alimentazione
Cosa sarebbe oggi la cucina italiana senza il pomodoro?
“La scoperta del pomodoro ha rappresentato, nella storia dell’alimentazione, quello che, per lo sviluppo della coscienza sociale, è stata la rivoluzione francese”. Così lo scrittore napoletano Luciano De Crescenzo nel tradurre l’impatto della pianta nella cucina e nella tradizione culinaria a cui nel tempo ha dato origine. Originaria del Cile e dell’Ecuador, dove per effetto del clima tropicale offre i suoi frutti tutto l’anno, la sua coltivazione era diffusa già in epoca precolombiana in Messico e Perù. Fu poi introdotta in Europa dagli Spagnoli nel XVI secolo, ma non come ortaggio commestibile, bensì come pianta ornamentale poichè all’epoca era ritenuta addirittura velenosa per il suo alto contenuto di solanina, sostanza considerata all’epoca dannosa.
Nel 1544 l’erborista italiano Pietro Matthioli non a caso la classificò fra le specie velenose. Servirono due secoli al pomodoro per raggungere le cucine europee e diventare un prodotto imprescindibile di tantissime ricette e dell’alimentazione popolare. Soltanto alla fine del Settecento la coltivazione a scopo alimentare del pomodoro conobbe un forte impulso in Europa, principalmente in Francia e nell’Italia meridionale. Ma mentre in Francia il pomodoro veniva consumato soltanto alla corte dei re, a Napoli si diffuse rapidamente tra la popolazione storicamente oppressa dalla fame. Bisognerà tuttavia attendere l’Ottocento perchè il pomodoro fosse inserito nei primi trattati gastronomici europei, come nell’edizione del 1819 del “Cuoco Galante” a firma del grande cuoco napoletano di corte Vincenzo Corrado, dove sono descritte molte ricette con pomodori farciti e fritti.
Anche l’introduzione del tabacco e del cioccolato ebbe un effetto enorme prima nello stile di vita degli aristocratici e dei ricchissimi per poi scendere nei vari strati della società europea fino anche ai più poveri.
Un caso che divenne persino tragico, dimostra quanto fosse stato profondo l’impatto economico e sociale della patata.
Considerata il nuovo cibo per i poveri, ci volle poco tempo perché in Irlanda diventasse la base dell’alimentazione della popolazione rivoluzionando completamente abitudini alimentari che erano andate avanti per secoli. Quando tra il 1850 e il 1852, a causa di una malattia che colpì la coltivazione di questo tubero, venne a mancare, non solo diventò la causa di una grave carestia che colpì l’isola. Ma quella carestia, che colpì una percentuale enorme della popolazione fino a farla morire di fame, fu il potente motore che spinse migliaia e migliaia di irlandesi ad emigrare nelle Americhe.
Infine il colonialismo fece un ulteriore passo con l’introduzione di altri prodotti dalla colonie. Per dare un esempio divertente, il famoso Worcestershire Sauce considerato icona della moderna cucina inglese e ora utilizzato spesso anche in Italia, fu il risultato di un tentativo di copiare la ricetta di una salsa originariamente prodotta in una colonia britannica nel subcontinente indiano.
Ogni volta che andiamo al supermercato vediamo prodotti nuovi, spesso il risultato dei cambi della demografia italiana a causa dei nuovi immigrati.
Però, dovremmo ricordare e capire che questi nuovi prodotti e cambiamenti non sono nuovi al Paese, sono millenari e hanno sempre fatto parte della nostra Storia e tradizione sin da prima della nascita dell’Impero Romano.
La nostra Cultura è ricca grazie a questi prodotti arrivati da Paesi lontani e ai tanti concetti e conoscenze introdotti dall’estero in un passato tanto lontano che pensiamo sia nostro senza più ricordare che fu merito di una “contaminazione”.
In questo senso, continuare ad essere aperti a idee nuove, non fa altro che rendere il nostro futuro più ricco di occasioni di crescita.