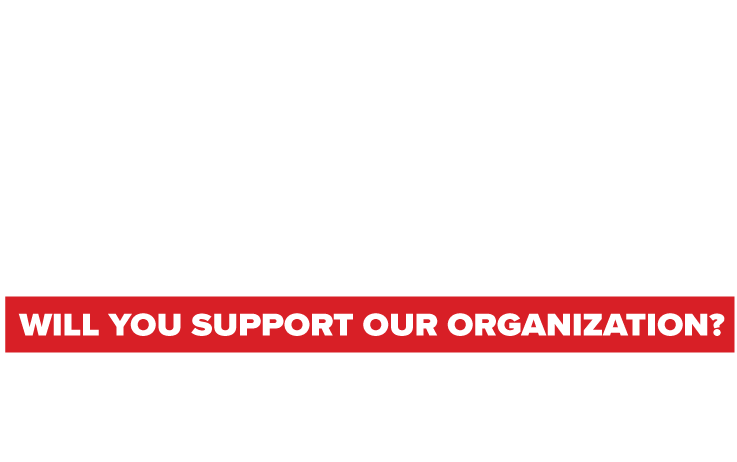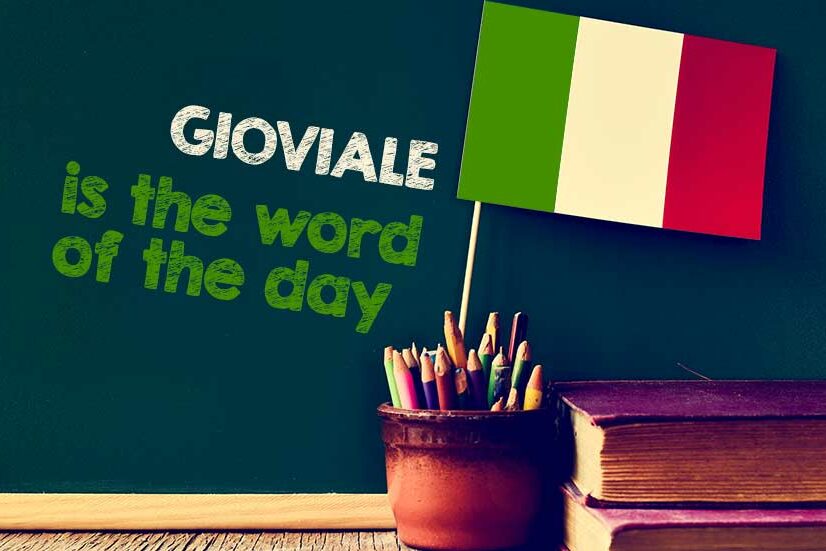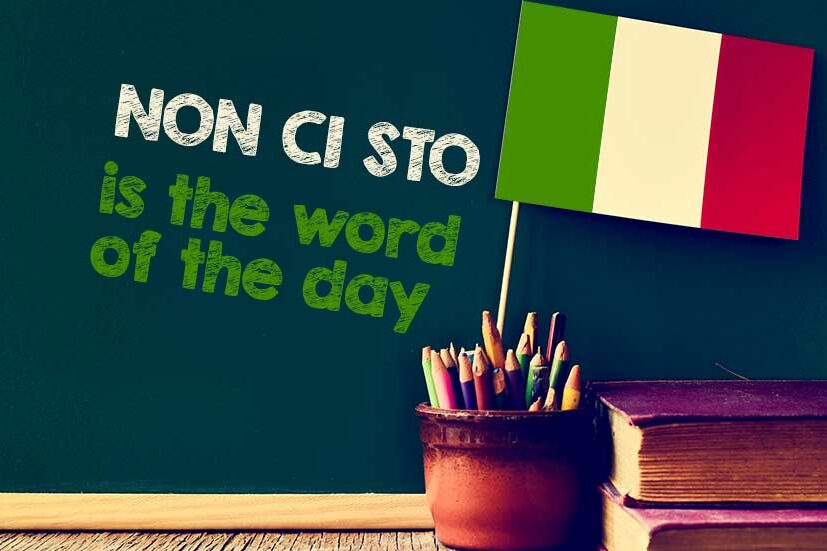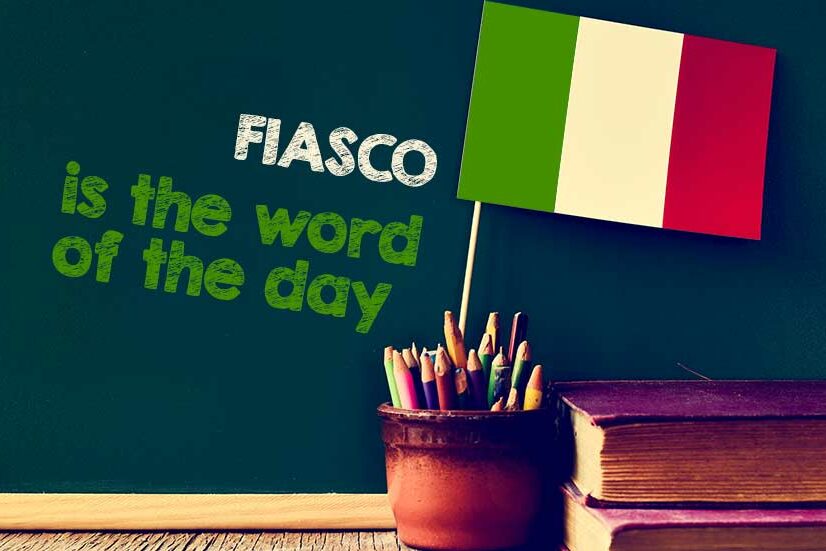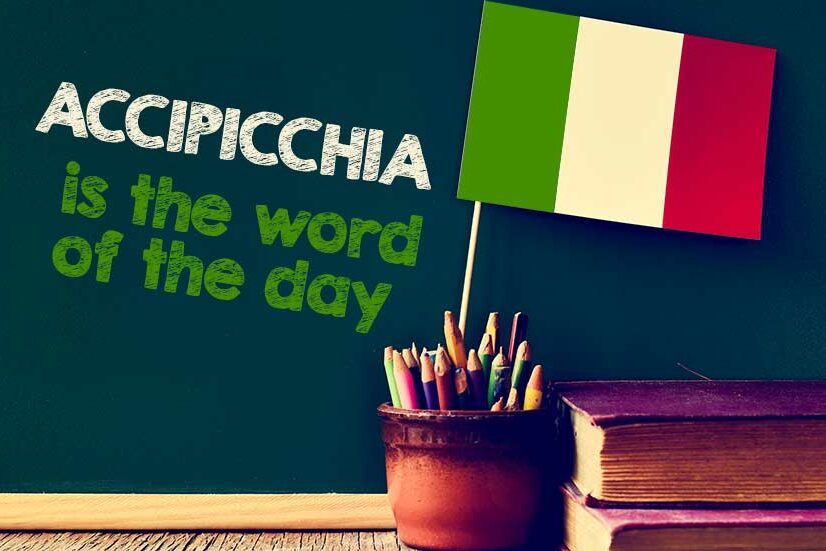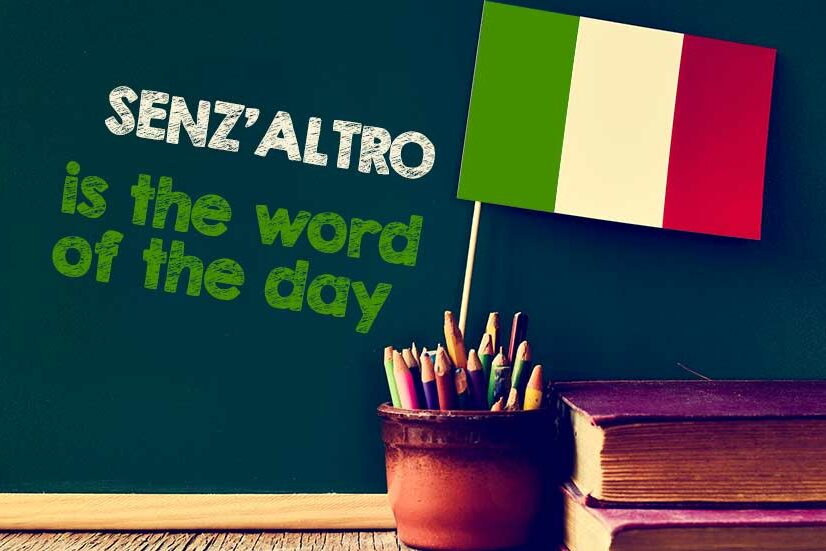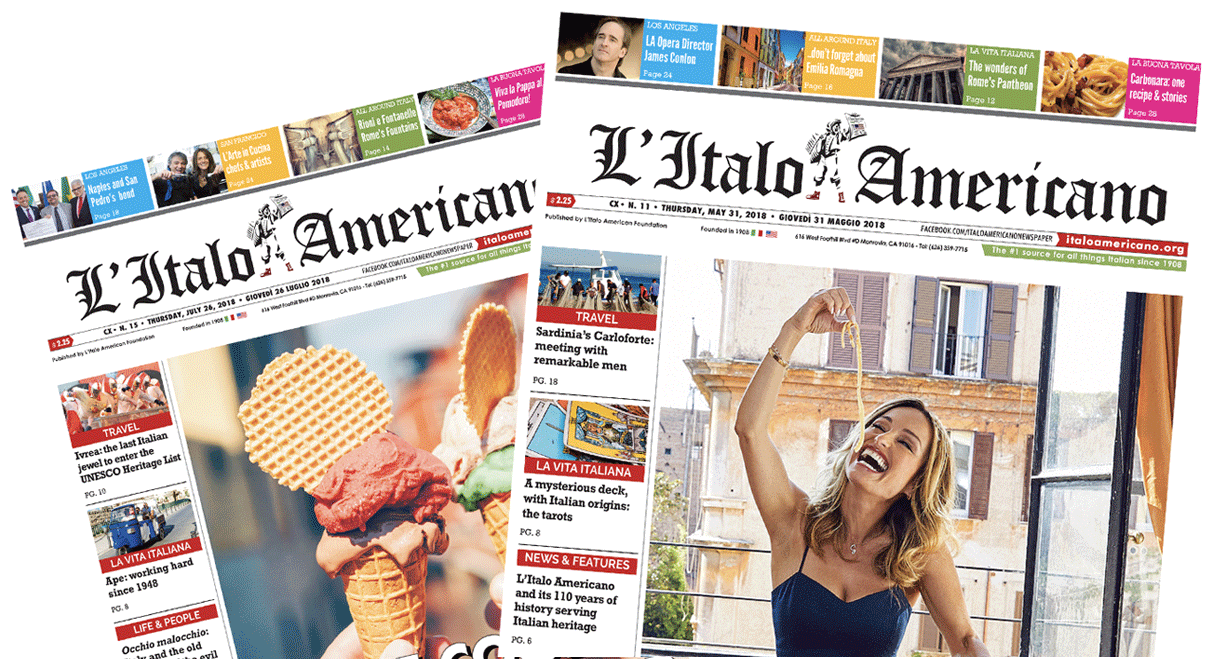Nel secondo dopoguerra, la Rca (Radio Corporation of America), con sede a New York, era una delle più importanti case discografiche degli Stati Uniti. Fondata nel 1919 come compagnia radiofonica, nel 1929 aveva acquistato la Victor Talking Machine Company, entrando così nel mercato discografico.
Nel 1949, Frank M. Folsom, vice presidente della Rca Victor, fu ricevuto in udienza privata da Papa Pio XII, il quale in ricordo dei bombardamenti americani che colpirono il quartiere di San Lorenzo, gli chiese l’installazione di una fabbrica nel borgo romano. La società americana, già decisa ad aprire uno stabilimento in Italia, dopo quell’incontro scelse Roma come sede, inizialmente vicino a Villa Borghese e, nel 1951, al Km 12 della via Tiburtina.
Durante i primi anni furono stampati per lo più dischi di provenienza statunitense (Harry Belafonte ed Elvis Presley), anche perché la casa madre promuoveva pochi artisti italiani, tra questi: Domenico Modugno, Nilla Pizzi e Katyna Ranieri.
Alla fine del 1954 la sede americana pensò di chiudere la società italiana, il cui bilancio era in perdita ma Papa Pio XII incaricò uno dei suoi segretari laici, Ennio Melis, di verificare lo stato dell’azienda, questi ne intravide l’enorme potenziale e riuscì a evitarne la chiusura.
Le prime scelte importanti di Melis furono di abbandonare il 78 giri, in funzione del nascente 45 giri, e di assumere come direttore artistico Vincenzo Micocci. I due decisero la costruzione di nuovi studi di registrazione e assunsero giovani e promettenti musicisti, tra cui Ennio Morricone e Luis Enriquez Bacalov. I primi cantanti ingaggiati furono i “quattro moschettieri”: Nico Fidenco, Gianni Meccia (per lui fu coniato il termine “cantautore”), Jimmy Fontana ed Edoardo Vianello.
Negli anni successivi la Rca mise sotto contratto Rita Pavone e Gianni Morandi, e ingaggiò come direttore artistico Nanni Ricordi, che portò “in dote” Sergio Endrigo, Gino Paoli, Luigi Tenco ed Enzo Jannacci. Fu in quel periodo che la Rca Italiana diventò la casa discografica leader per le vendite, abbinando la canzone d’autore a quella di consumo.
La sede di Via Tiburtina non era soltanto il luogo degli uffici, delle registrazioni e della stampa dei dischi, ma una vera e propria “cittadella della cultura”. Uno dei luoghi più frequentati era il bar, in cui per anni si ritrovarono gli artisti e dove nacquero idee, collaborazioni e nuove canzoni. Tra i frequentatori: Pier Paolo Pasolini e Arthur Rubinstein, che era solito consumare il suo uovo alla coque, John Huston e Aurelio De Laurentiis, soltanto per citare qualche nome.
Un altro importante luogo di ritrovo è stato il “Cenacolo”, una sorta di campus situato in via Nomentana; tutti i giorni in quelle piccole sale, allestite con vari strumenti e registratori a 4 piste, si incidevano e ascoltavano canzoni e provini.
Tra i numerosi artisti che incisero negli stabilimenti romani della Rca, ci fu anche Franck Sinatra
Il successo dei dischi degli anni ‘60 fu spesso dovuto agli arrangiamenti di Morricone e Bacalov, che non si limitavano all’orchestrazione, ma cercavano nuove sonorità ed effetti. Inoltre, un ruolo importante lo ebbe anche la tecnologia, notevolmente all’avanguardia per quell’epoca.
Gli studi Rca ospitarono grandi artisti internazionali come il pianista Arthur Rubinstein, John Houston (per la registrazione della colonna sonora del film “La Bibbia”) e Frank Sinatra, che incise i brani per i Caroselli della Perugina.
Visto il successo, la Rca decise di continuare a investire sui giovani talenti italiani e grazie alle intuizioni di Sergio Bardotti furono lanciati i Rokes di Shel Shapiro, i Primitives di Mal, Patty Pravo, Ricky Shayne, Dino e Lucio Dalla.
Gli anni Settanta videro l’affermazione di nuovi artisti tra cui Claudio Baglioni, Ivano Fossati, Renato Zero, Gabriella Ferri, Nicola di Bari, Nada, Riccardo Cocciante, Anna Oxa, Ron, Antonello Venditti, Francesco De Gregori e Rino Gaetano (gli ultimi quattro provenienti dalla It di Micocci), inoltre, fu raggiunto l’accordo per la distribuzione della Numero Uno, la casa discografica di Mogol e Lucio Battisti.
In quegli anni si ebbe un primo periodo di crisi economica, dovuto al calo del mercato discografico italiano e a una serie di errori, tra cui il flop delle cassette Stereo 8, imposto dalla casa madre. Nel 1978 la Rca perse Baglioni e Venditti e alcuni cantanti non raggiunsero gli obiettivi di vendita previsti.
Melis aveva percepito il potenziale di artisti quali Piero Ciampi, pur essendo consapevole della sua inaffidabilità. Andando contro il parere di tutti lo tenne per lungo tempo in azienda, credeva che quella “piccola luce”, che Ciampi emanava, fosse importante per tutti gli altri autori, per fare vedere che la canzone non era soltanto svago o competizioni canore, ma poteva entrare in zone di comunicazione più elevate. Il tempo gli ha dato ragione, anche se soltanto dal lato artistico.
Agli inizi degli anni ‘80 altri artisti lasciarono la Rca (tra questi Paolo Conte, Francesco De Gregori e Ivano Fossati) e non furono ingaggiati personaggi di rilievo. Una delle rare eccezioni fu Luca Carboni.
Nel 1983, avendo saputo che la Bmg Ariola era interessata all’acquisto della Rca e che quindi si doveva ridurre il personale (da 600 a 200 dipendenti), Melis decise di lasciare l’azienda.
Gli edifici della sede storica di Via Tiburtina sono stati in parte demoliti. Oggi restano gli studi di registrazione, la palazzina dirigenti, il magazzino e pochi altri. Questi palazzi sono utilizzati come magazzini per ditte di abbigliamento e calzature.
Ogni anno gli ex-dipendenti della Rca organizzano un raduno con relativa visita allo stabilimento, un’occasione per ritrovarsi e per ricordare le tante storie vissute tra quelle mura che hanno ascoltato nascere gran parte degli artisti e della storia musicale nazionalpopolare. L’idea di realizzare un museo sta diventando sempre più sentita e a nostro avviso anche dovuta.