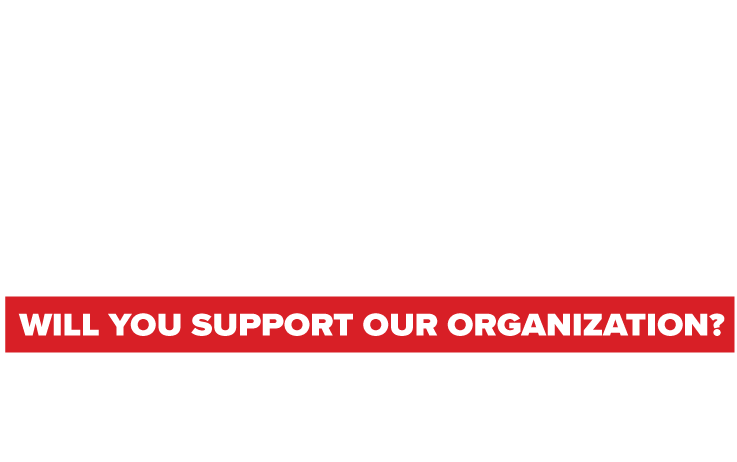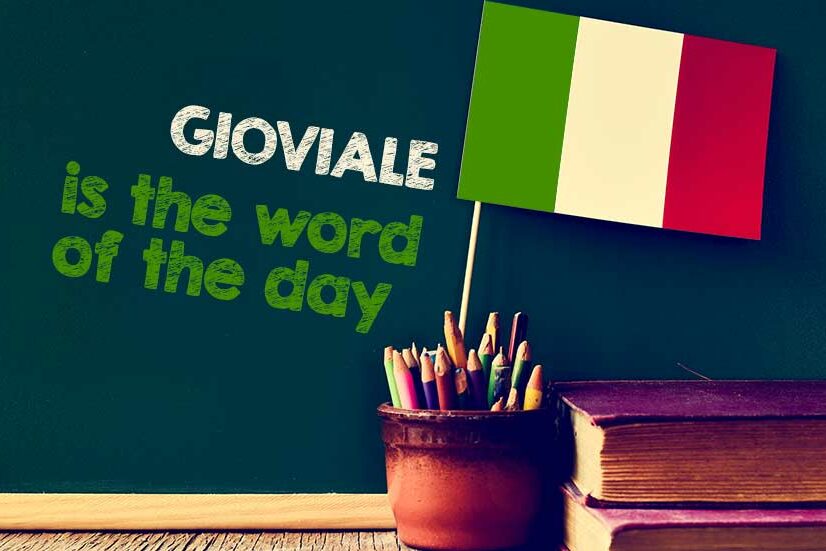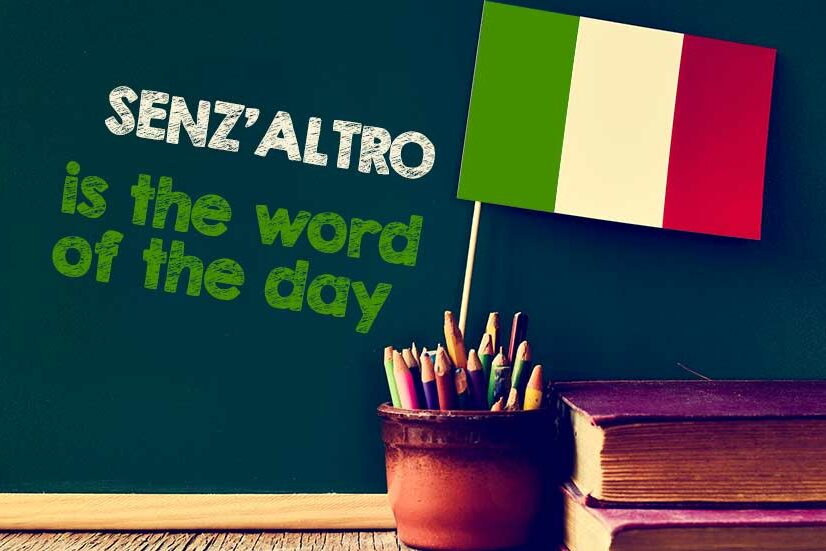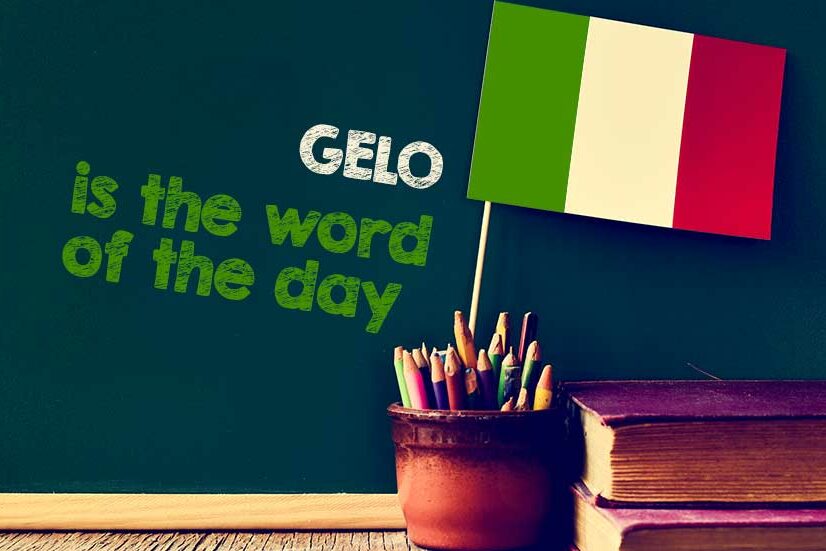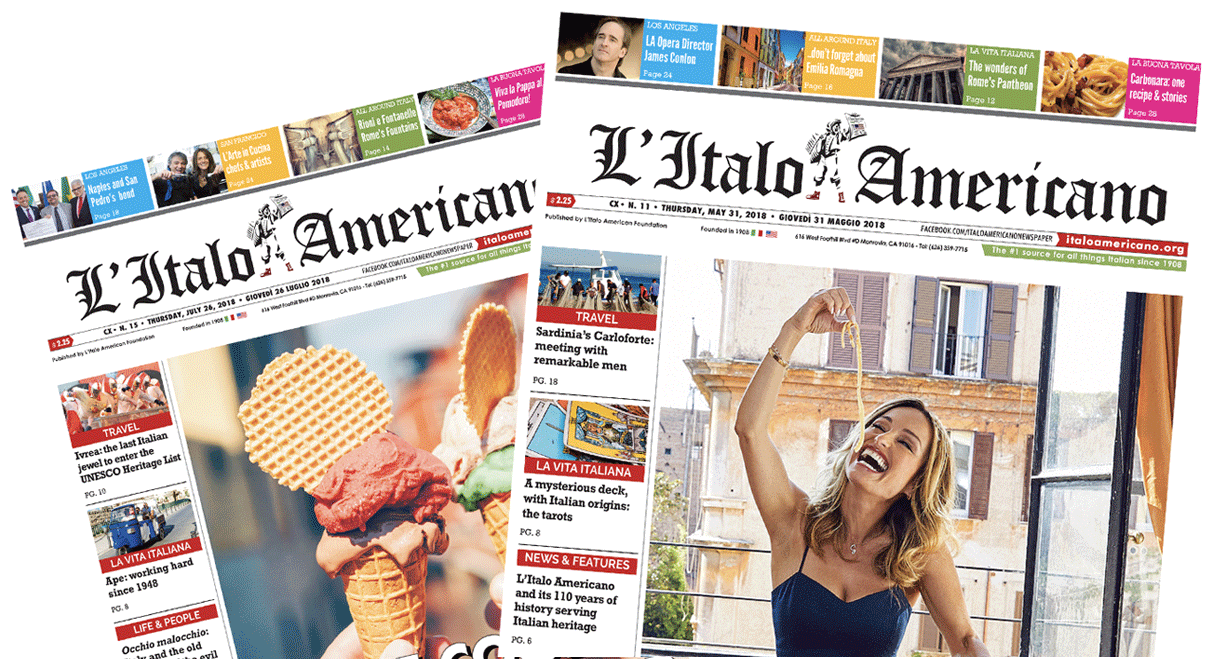Tra il II e la prima metà del I secolo a.C., i pirati infestavano il Mar Mediterraneo. Le coste tirreniche non erano esenti dai saccheggi e dalle attività predatorie tanto che la litoranea toscana è punteggiata da fortezze, fortini, torri, strutture difensive e di avvistamento.
Per proteggere il territorio, le popolazioni e soprattutto gli insediamenti produttivi, a Poggio del Molino fu costruito un forte con tre torri di avvistamento, cinto da un muro perimetrale molto spesso su cui si aprivano due porte di accesso, che definiva un’area quadrangolare, la cui porzione settentrionale è franata a mare.
Venuto meno il pericolo dei pirati, nella seconda metà del I secolo a.C., il forte oggi nascosto da una folta vegetazione a nord di Piombino, in provincia di Livorno, fu trasformato in fattoria, una vera e propria villa rustica, con un quartiere residenziale e una cetaria, un settore per la produzione della salsa di pesce, il pregiato garum latino.
L’impianto produttivo, che contava su oltre dieci vasche, chiuse i battenti nella seconda metà del I secolo d.C. e l’intero edificio fu trasformato in villa marittima.
Attorno a un ampio peristilio centrale, si affacciarono così un complesso termale, un quartiere domestico-servile (con un pozzo, una cisterna per lo stoccaggio dell’acqua e una piccola rimessa per gli attrezzi, una cucina e un piano superiore destinato all’alloggio del personale) e un quartiere residenziale, composto da camere da letto e sale da pranzo.
Oggi le stanze completamente scavate sono cinque ma altrettante stanno venendo alla luce. Tutte conservano, piú o meno bene, un pavimento a mosaico, bianco e nero con decorazione geometrica o floreale. Negli anni Ottanta, all’inizio degli scavi, è emerso il “Mosaico della Medusa”: un riquadro è decorato con la testa di Medusa in tessere policrome di pasta vitrea su fondo bianco; dai capelli spuntano coppie di serpenti, due dei quali si incrociano sotto il mento.
Del quartiere termale, attualmente, sono stati riportati alla luce la sala per i bagni caldi (calidarium), con l’adiacente forno (praefurnium) e due vasche, una circolare e una ellittica, per i bagni freddi (frigidarium).
L’abbandono definitivo della villa a precipizio sul mare, e dell’intero sito, è databile agli inizi del IV secolo.
Fin qui la storia o meglio la ricostruzione storica ad opera degli archeologi che 30 anni fa avevano individuato in Poggio del Molino un terzo lotto dell’area archeologica che include le necropoli etrusche e romane della vicina Populonia, l’unica città etrusca edificata sul mare nel IX secolo a.C., che acquisì importanza dal VII secolo a.C. raggiungendo il massimo splendore nel IV secolo a.C. per poi passare nell’orbita romana intorno alla metà del III secolo a.C.
Da questo momento in poi inizia la ricerca di finanziamenti ma soprattutto l’idea di poter, ciascuno, dare il proprio contributo personale alla scoperta di un tassello di questo luogo prezioso in cui convivono tre livelli archeologici.
Come in una preziosa scatola cinese, indagando, è possibile ricostruire la storia della villa che si è insediata sopra lo stabilimento produttivo che a sua volta aveva soppiantato l’insediamento militare.
Ambiente termale del sito romano di Poggio del Molino, in Toscana, che oggi ospita un cantiere-scuola di archeologia (Ph. in pagina B. Minafra)
IL PROGETTO ARCHEODIG
Dal 2008, da maggio a settembre, il sito toscano di Poggio del Molino si popola di volontari, di studenti liceali e universitari, italiani e stranieri. Il cantiere-scuola di archeologia è aperto a tutti e tutti possono fare ricerca archeologica sul campo per farne un mestiere o coltivare una passione. Si va dalla movimentazione e setacciatura della terra, pulizia, lavaggio e siglatura dei reperti, all’impiego della cazzuola da scavo, per poi passare alla redazione della documentazione descrittiva, fotografica e grafica. Ciascuno versa un contributo per coprire le spese di vitto, alloggio e didattica sul campo.
UNIVERSITY OF ARIZONA
La lingua dello scavo è l’inglese. Il partner principale è la University of Arizona, il cui referente è il professor David Soren. L’accordo permette agli studenti di tutte le Università americane di partecipare alla field school e ricevere, attraverso l’Ateneo dell’Arizona, i crediti formativi (tuition).
Altri partner sono la Hofstra University di Long Island New York e lo Union College di Schenectady New York, con il quale partirà a breve un nuovo programma.
Poggio del Molino ospita anche un cantiere-scuola di Conservazione e Restauro del Mosaico Romano, diretto dalla Fondazione RavennAntica e coordinato dalla Soprintendenza Archeologica della Toscana. Studenti e neorestauratori hanno la possibilità, rarissima, di mettere mano su mosaici di epoca romana imperiale ancora in situ.
Il cantiere e gli studenti sono coordinati da restauratori professionisti, tra cui la responsabile del Laboratorio di Restauro di RavennAntica, Paola Perpignani.
Il programma di ricerca e didattica prevede l’allestimento di Laboratori di Antropologia Fisica e Archeologia Forense, coordinati dagli antropologi del progetto AnthroLab. L’obiettivo è quello di ricostruire modi di vita e di morte della popolazione di Populonia e del suo territorio in età etrusca e romana, attraverso lo studio di un campione di scheletri provenienti dagli scavi di Baratti-Populonia.
SCAVI APERTI A TUTTI
L’archeologa dell’Università di Firenze Carolina Megale è il direttore scientifico del Progetto Archeodig e spiega a L’Italo-Americano come è nato questo cantiere comune di studenti e volontari.
Quattro anni di scavi poi, finiti i fondi, vi siete fermati. Per ripartire vi siete affidati al crowdfunding.
Cercando finanziamenti diversi da quelli statali, abbiamo aperto le porte della ricerca al pubblico e ai volontari che partecipano attivamente alla ricerca di sostenitori. Il nostro supporter principale è Earthwatch Institute che dal 2009, ogni anno, copre il nostro budget di spesa attraverso il contributo di volontari che da tutto il mondo, la maggior parte americani ma anche inglesi, tedeschi e australiani, ci consentono di lavorare 12 settimane l’anno. Poi ci siamo rivolti alle università americane.
Così da tre anni abbiamo una Field School con l’Università dell’Arizona, prossimamente ne avvieremo un’altra con lo Union College di Schenectady. Ora sto lavorando con un College vicino Boston.
Ovviamente non arrivano frotte di studenti, ognuno però è una goccia di lavoro preziosissimo. E’ un’esperienza unica per loro, importante per noi.
“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. E’ l’articolo 4 della Costituzione italiana.
Moltissimi cittadini, in tutto il mondo, sono coinvolti nella ricerca scientifica: diventano in questo modo “citizen scientists”, cittadini-ricercatori, cittadini-scienziati, volontari del sapere.
Lo scavo di Poggio del Molino ospita una vera e propria spedizione scientifica, organizzata in collaborazione con l’associazione no profit statunitense Earthwatch Institute, in cui i volontari entrano a far parte del mondo della scienza e traggono il massimo della soddisfazione nel conoscere e partecipare al progresso comune.
L’archeologia sul campo insegna ai giovani quanto sia importante dare il proprio contributo personale.
È questa la particolarità di Poggio del Molino. Non è uno scavo di emergenza, non è uno scavo di ricerca a cui partecipano professionisti ma è un cantiere scuola per quelli che si vogliono avvicinare all’archeologia. E questo sistema ci permette di essere sostenibili perché i partecipanti pagano una quota che serve a sostenere le loro spese di vitto e alloggio e un contributo per lo scavo che noi restituiamo in didattica. Didattica in inglese e in italiano.
Dal 2008, un mecenatismo fatto di piccole donazioni liberali rende possibile lo scavo archeologico. Cosa fate con i fondi che raccogliete?
Oltre a finanziare lo scavo abbiamo il problema dei mosaici e della conservazione di quanto riportato alla luce, perché la villa ha tre fasi di insediamento principali, ciascuna da proteggere una volta scoperta.
Nasce infatti come fortezza nel II secolo a.C. contemporaneamente all’acropoli romana di Populonia per controllare il territorio e difenderlo da eventuali attacchi dei pirati che nel II secolo a.C. infestavano il Mediterraneo. Quando nel 67 a.C. Pompeo viene incaricato dal Senato di eliminare il problema, i pirati vengono effettivamente debellati ma proprio allora la funzione difensiva del forte viene meno.
La fortezza, che doveva essere pubblica, viene acquisita da un esponente importante della famiglia dei Cecina di Volterra, che ci fa una fattoria per produrre salsa di pesce. Abbiamo trovato vasche per il garum che risalgono al periodo augusteo, quindi ai primissimi anni del I secolo d.C.
Quando finisce l’economia etrusca basata sulla lavorazione del ferro cioè, c’è una riconversione produttiva. Al primo posto c’è la risorsa marittima.
Poi però anche la produzione del garum subisce una battuta d’arresto perché quello prodotto in Nordafrica, in Spagna e in Portogallo costa meno e viene esportato in grandi anfore in tutto il Mediterraneo. Il garum italico degli inizi dell’età imperiale, invece, è commerciato in anfore più piccole perché più prezioso ma anche più costoso.
Il sito viene così riconvertito in villa d’ozio. Non si produce più e l’area diventa un quartiere residenziale con stanze per dormire e per mangiare, vengono realizzati mosaici pavimentali, una zona termale e un quartiere domestico.
E qui siamo al punto centrale visto che una volta scoperte, le cose vanno protette e rese accessibili a studiosi e cittadini.
Questi mosaici per noi sono una scoperta straordinaria perché rendono il sito pregevole, meritevole di essere visitato. Però sono un problema perché vanno messi in sicurezza. Ci sono due strade: o si risotterrano o si restaurano. Noi abbiamo scelto il restauro in situ attivando una collaborazione con la fondazione RavennAntica che con noi organizza una Field School di restauro dei mosaici.
Quindi offriamo un cantiere-scuola non solo per lo scavo ma anche per il restauro dei mosaici. Lo scorso anno hanno partecipato solo studenti italiani, ma da quest’anno parteciperanno anche volontari stranieri da tutto il mondo.
Recentemente è stato affidata anche la progettazione delle coperture dei mosaici.
Il lavoro da fare è ancora lungo: oltre allo scavo, sono in programma il restauro dei sei pavimenti musivi finora messi in luce, le coperture del quartiere residenziale e di tutto il complesso termale; l’ambiente sotterraneo va scavato, messo in sicurezza e reso accessibile per le visite; occorre progettare un percorso per i visitatori dotandolo di apparati didattico-illustrativi.
Il progetto si alimenta della partecipazione del pubblico. Il nostro ruolo è quello di mediatori tra passato e presente, con uno slancio verso il futuro per garantire alle generazioni che verranno la salvaguardia del loro patrimonio.