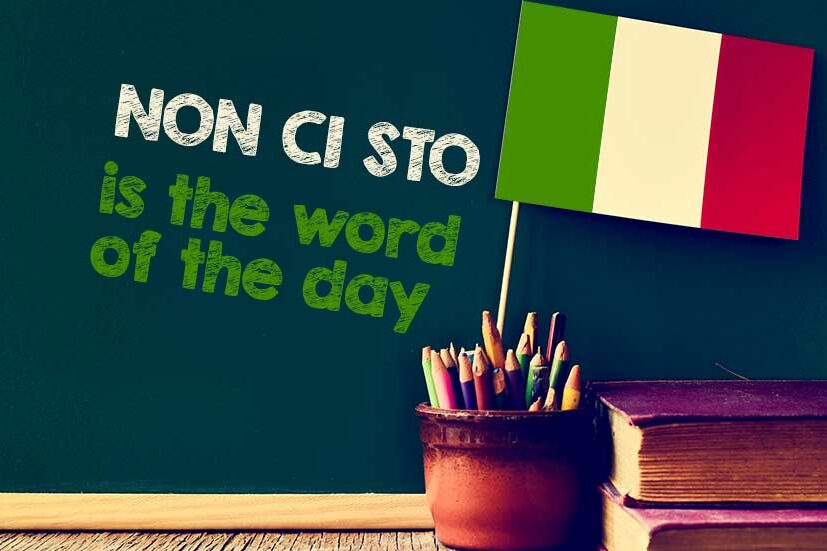Francesco Petrarca rappresenta uno fra i poeti più famosi della lirica italiana delle origini. Nacque ad Arezzo nel 1304 da un facoltoso uomo di legge, ser Petracco, che era stato inviato in esilio da Firenze in questa città, a causa delle sue convinzioni politiche. Siamo nel periodo più acceso delle lotte fra Guelfi (sostenitori del Papa), a loro volta divisi in due fazioni Guelfi Bianchi e Guelfi Neri, e Ghibellini (sostenitori dell’Imperatore). Un’epoca non troppo lontana dalla nostra, se si vuole osservare, in quanto a molteplicità di partiti e fazioni, perlomeno in Italia.
Francesco venne alla luce in esilio e questo rimarrà sempre nell’animo dell’artista come una ‘nota dolente’, tanto è vero che scriverà molti anni più tardi di non trovarsi a casa in nessun luogo. Per volontà paterna intraprese studi di Diritto, ma ben presto si accorse che le sue vere passioni erano la letteratura e l’antichità romana. Sembra essere un dato storico l’incontro in Francia con Laura, una donna sposata, molto bella, di cui venne fatto un ritratto dal grandissimo pittore Simone Martini (purtroppo oggi andato perduto). Secondo altri critici, però, Petrarca non avrebbe mai conosciuto né frequentato questa donna, ma se ne sarebbe servito unicamente come finzione letteraria per esprimere la propria arte poetica. Lo stesso gioco di doppi sensi che è stato ravvisato all’interno del nome proprio della donna (Laura: dal latino ‘aurum’, metallo incorruttibile come la purezza del sentimento del poeta, ovvero ‘laurus’, alloro, la pianta che conferiva il titolo di’ Vate’ ai grandi versificatori, oggi ‘laurea’) fa propendere a maggior ragione per questa seconda interpretazione. Comunque sia, il poeta nel sonetto introduttivo del Canzoniere, ‘Ove sia chi per prova intenda amore, spero trovar pietà, nonché perdono…’, la sua opera maggiore, definisce il suo amore per Laura, la donna da lui amata, “errore” cioè “peccaminoso”. Perché questo giudizio tanto negativo? Perché si tratta di una passione terrena, non di un sentimento platonico ed etereo come quello provato da Dante Alighieri per la sua Beatrice, che colloca, perfetta e celestiale, nel Paradiso della Divina Commedia.
Il Canzoniere stesso, d’altronde, è la storia, raccontata in chiave poetica, della vita interiore del poeta riconosciuto quale fondatore dell’Umanesimo, indispensabile premessa culturale del Rinascimento, con cui si sottolinea una netta distanza tra il mondo medioevale, caratterizzato da una visione della vita, che poneva Dio al centro dell’Universo e imponeva all’uomo una totale sottomissione al volere e al potere della Chiesa e la visione in cui l’uomo è posto al centro dell’Universo ed è considerato artefice e padrone del suo destino. Petrarca si rivolge, quindi, a chi tra i suoi lettori ha vissuto l’esperienza travolgente dell’amore che colloca l’innamorato in una posizione d’inferiorità, di debolezza, di derisione.
Chi tra gli uomini ha veramente e in profondità provato questo sentimento, potrà comprendere il dissidio tra il “volere” e il “potere”, tra il “volere” riscattarsi da questo umiliante giogo, da questa schiavitù e il “non esserne capace”. L’uomo, quando ama davvero, perde se stesso, la solidità della propria personalità, si lascia andare fino al punto da non ritrovare più la propria dignità di fronte agli altri, da non leggere più in modo oggettivo la realtà, da non scorgere più i difetti dell’amata, le sue derisioni, i suoi rifiuti, più o meno palesi.
Petrarca afferma in un sonetto “favola fui gran tempo…”: ma quando avviene allora il riscatto di questo infelice, di questa vittima di Eros? Quando finalmente apre gli occhi, legge la realtà per come essa è, allora prova una grande vergogna di se stesso, di come si è comportato, di come ha parlato e solo allora arriva a concludere che “quanto piace al mondo è breve sogno”.
La vita può presentare attimi di illusione che possono vestirsi di eternità, ma questi sono destinati a svanire nel nulla in breve tempo, non appena il sogno scompare, non appena ci destiamo. La riflessione del Petrarca sull’evanescenza delle illusioni, ritornerà a distanza di molti secoli nella famosa lirica del Leopardi “A se stesso” nella quale il poeta, rivolgendosi al proprio cuore come ad un reale interlocutore, arriverà ad affermare che “il mondo è fango”.
Già nel mondo greco arcaico, il poeta Archiloco si era rivolto al proprio cuore invitandolo a diffidare delle illusioni, delle apparenze, delle gioie troppo facili e rapide da conseguire, esortandolo invece a trovare un equilibrio interiore, un’armonia, a rifuggire dagli eccessi perché questi come possono portare tra le stelle, possono ugualmente, e in tempi brevi, scaraventare nelle profondità degli abissi.