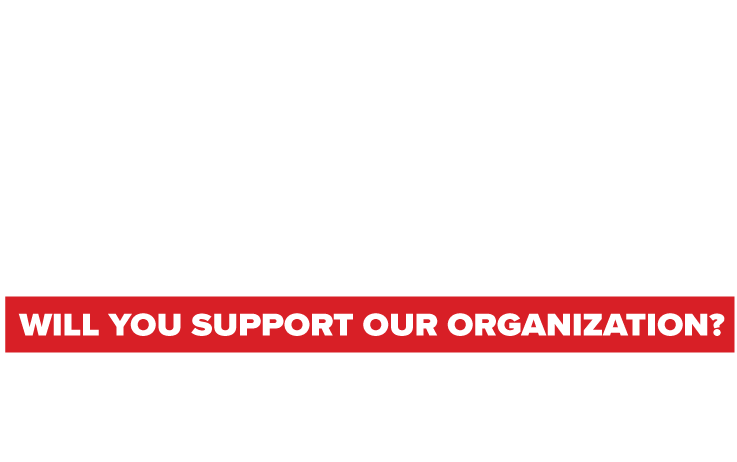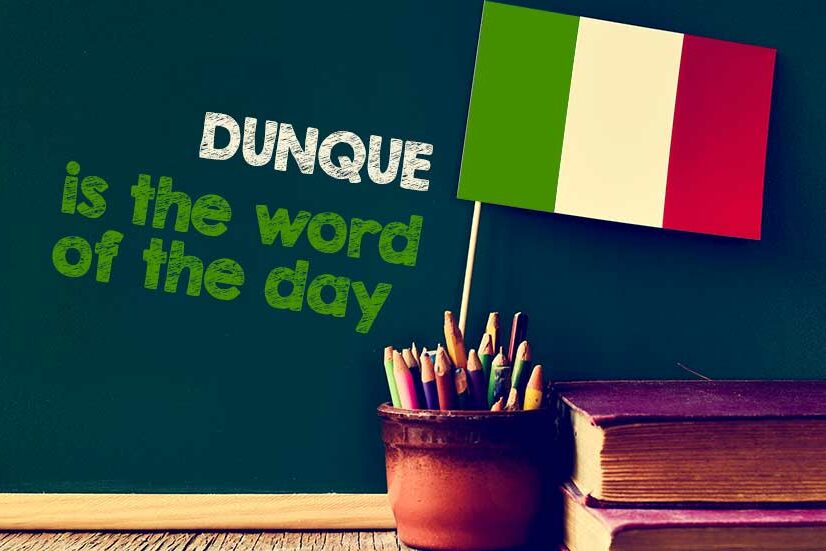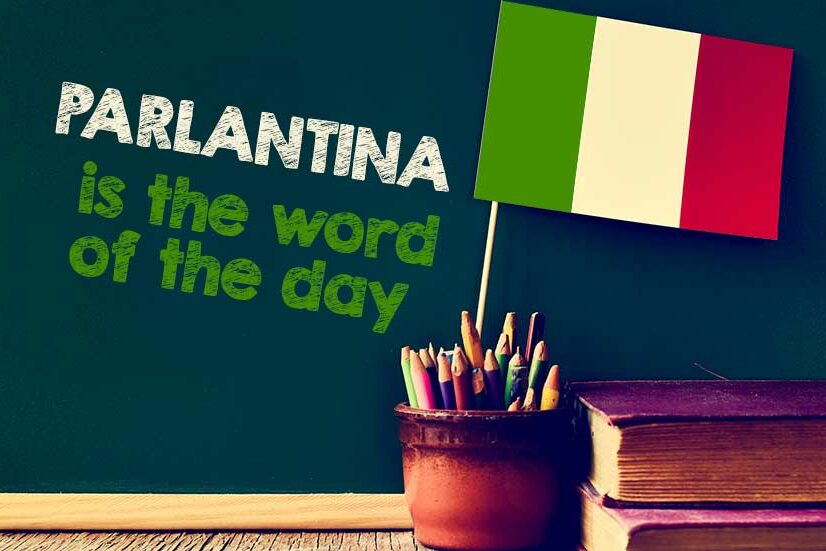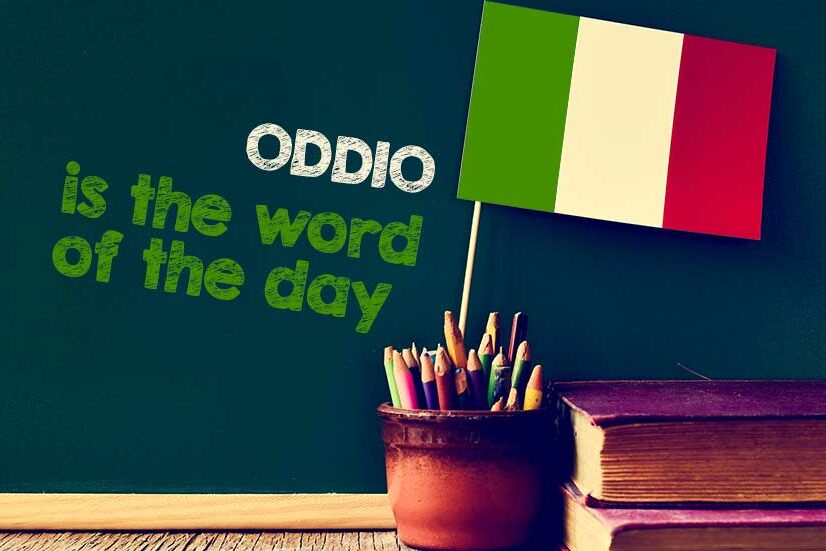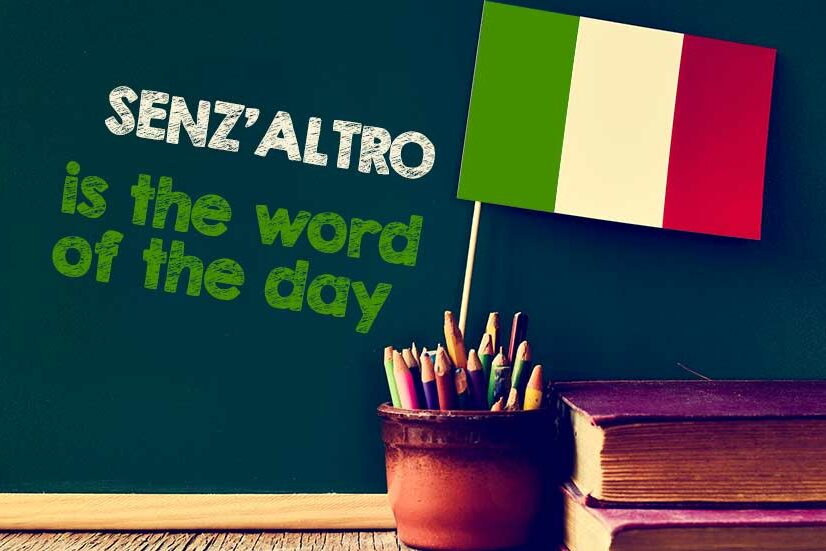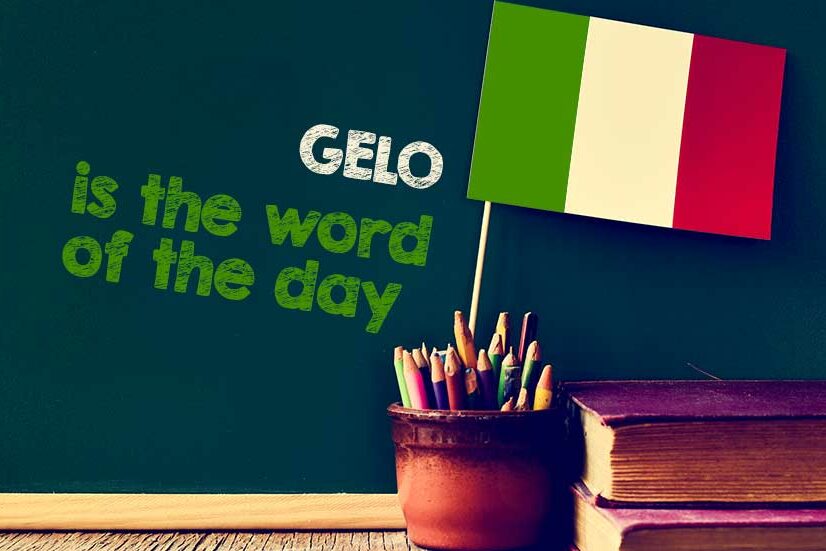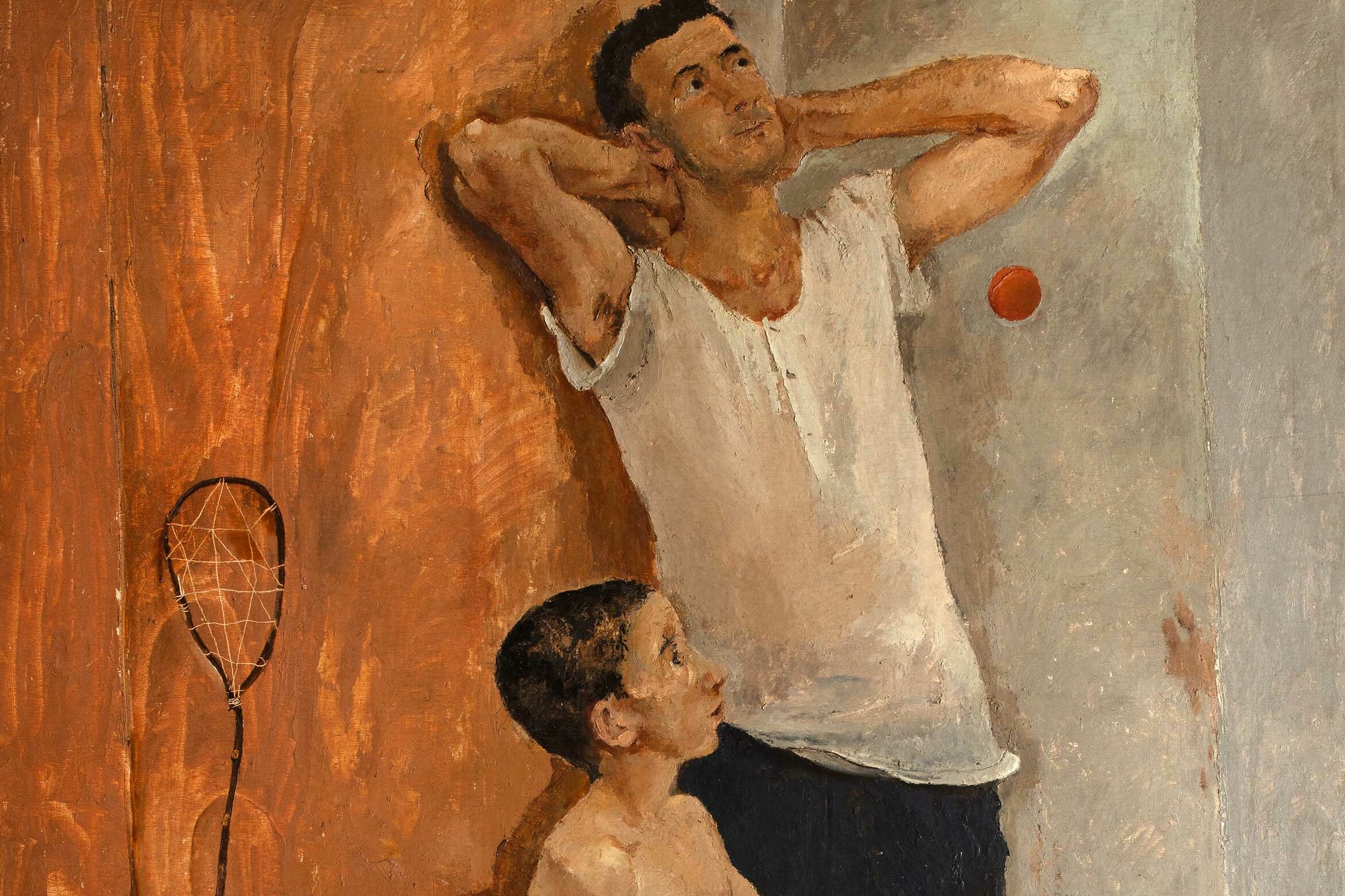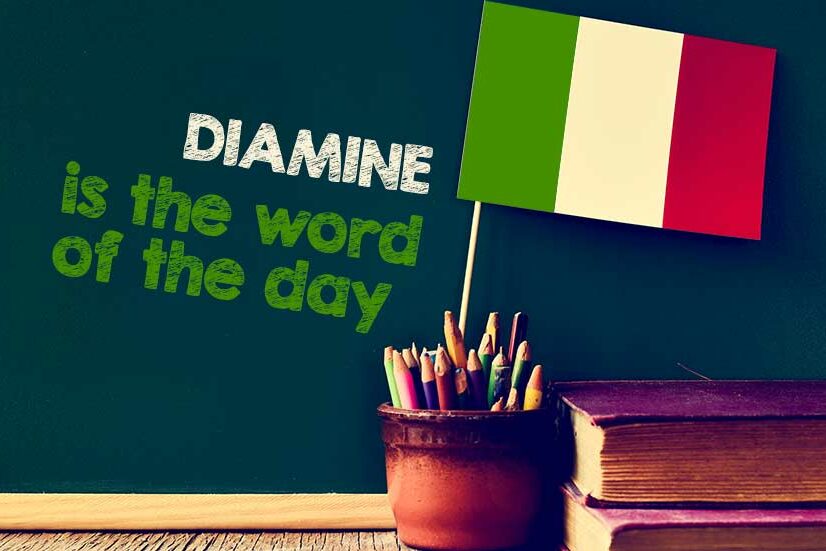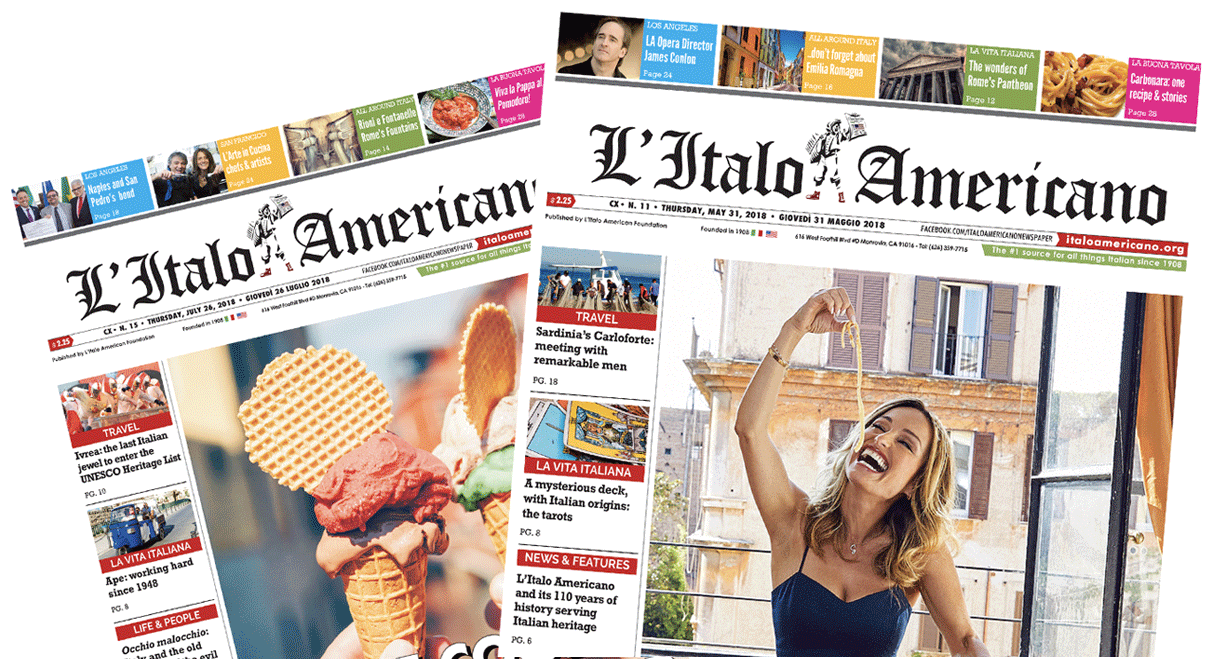Discovering — or simply knowing — that you have a relative living on another continent, in a country different from your own, and that your ancestors came from somewhere else, inevitably sparks a touch of curiosity. That faraway place becomes a distance to bridge, because the experience of migration leaves lasting traces—within us and behind us.
Everything Is Illuminated, a 2005 American film based on Jonathan Safran Foer’s memoir, tells the story of a journey that is both physical and spiritual. The protagonist follows in the footsteps of his grandfather, who had been forced to emigrate from Ukraine to the United States. A self-described “collector of family memories,” he sets off on a backward journey where the landscapes he encounters on the road slowly transform into journeys through personal and familial memory — pieces of a more intimate world that bind the past to his understanding of the present. The final gesture — bringing home a handful of soil from his ancestral land and scattering it on his grandfather’s grave — is a symbolic act of return, of reclaiming one’s roots.
For the millions of Italian Americans who feel fully integrated into American society today, the search for their Italian roots is not a rejection of the assimilation and integration they or their ancestors experienced. Rather, it is an effort to recover an additional layer of their identity. Often, this takes the form of a bureaucratic process: applying for Italian citizenship, obtaining a second passport, or passing on to their children — undoubtedly American by birth — a fragment of their past. The same impulse underpins the efforts of Italian American communities to preserve the rituals and folklore of their places of origin. It was true in the past, and it continues to be true today, as a way to feel closer to their roots.
In the early 20th century, for instance, emigrants from Patrica, a small town in Lazio’s province of Frosinone, settled in Aliquippa, in Beaver County, Pennsylvania. Every year on August 16, they celebrate the feast of San Rocco, the patron saint of their hometown. In a similar spirit, towns and cities in Italy are often twinned with communities abroad. These cultural bridges serve to preserve a connection with the past, to keep the umbilical cord from being completely severed. They help soothe the pain of separation — a separation that, for many, was not just physical, but emotional, personal, and familial. Millions of expatriates never returned home, never saw their relatives or friends again. To their descendants, they passed down an ancient longing to return, to keep the bond with their land of origin alive.
It’s no coincidence that, upon arriving in the New World, hundreds of thousands of former Italians sought out places that resembled the ones they had left. Islanders chose to live along the coasts. Southerners, used to sunshine and warmth, gravitated toward similar climates. People from Piedmont and Emilia-Romagna preferred hilly or rural landscapes. The migratory history of Meldola, a small town in Romagna, is emblematic. Since the late 19th century, it was the point of departure for a chain migration to Connecticut. The emigrants settled in Litchfield County, an area whose rolling hills and foothills resembled those of the Forlì region.
Similarly, emigrants brought with them their “territorial” expertise: they continued the trades they had practiced at home. In the early 1900s, hundreds of migrants from Roseto Valfortore, in the province of Foggia, founded the “borough of Roseto” in Northampton County, Pennsylvania, naming it after their hometown. Many found work in the local slate quarries, just as their ancestors had worked in stone extraction and processing in Puglia.
Maintaining a formal, legal link with one’s homeland goes well beyond paperwork. The effort, bureaucracy, and legal expenses typically involved in applying for Italian citizenship would seem more than enough to discourage anyone. Yet, many persist. People fight for recognition of their Italian origins, even if they have lived abroad for decades and may never return to Italy. Why? Because this is not just a legal matter, it’s a matter of identity. Wanting official recognition of one’s roots means reclaiming a part of one’s personal and family history. And for many, that step is essential to fully understanding — and becoming — who they are.
Scoprire o sapere di avere un parente che abita in un altro continente, in una nazione diversa dalla propria, che i propri antenati arrivavano da un altro Paese sollecita sempre un pizzico di curiosità. Quel luogo lontano da sé è spesso una distanza da colmare perché la storia migratoria lascia dentro e dietro di sé delle tracce.
Everything Is Illuminated è un film statunitense uscito nel 2005 che ha reso popolare l’autobiografia di Jonathan Safran Foer, in cui racconta il suo viaggio, sia fisico che spirituale, sulle orme del nonno, costretto ad emigrare dalla natia Ucraina negli Stati Uniti. Il protagonista, “collezionista di ricordi di famiglia”, decide di partire per un viaggio a ritroso dove i paesaggi incontrati on the road diventano poco a poco viaggi nella memoria familiare e personale, pezzi di un mondo più intimo che legano il passato al senso del proprio presente. Il gesto finale, quella “madre-terra” portata a con sé a casa e sparsa sulla tomba del nonno, è l’atto simbolico di un ritorno a casa, di un riappropriarsi delle proprie radici.
I milioni di italoamericani che oggi si sentono profondamente integrati nella società statunitense, quando cercano le proprie origini italiane, non stanno rinnegando il processo di assimilazione e integrazione di cui sono stati protagonisti. Piuttosto cercano di appropriarsi di un pezzo aggiuntivo della propria identità. Questo comporta spesso un passaggio burocratico con la richiesta della cittadinanza o del doppio passaporto o con la volontà di estendere ai figli, indiscutibilmente americani, un pezzo del proprio passato. E’ un po’ lo stesso principio per cui le comunità italoamericane che si trovano dall’altra parte del mondo, conservano gelosamente riti e folklore dei luoghi di partenza. Lo hanno fatto in passato e continuano a farlo oggi, per sentirsi più vicini alle origini. All’inizio del Novecento, ad esempio, gli emigrati da Patrica, piccolo centro laziale del Frusinate, che si insediarono ad Aliquippa nella contea di Beaver in Pennsylvania, il 16 agosto di ogni anno celebrano la festa di San Rocco, protettore della natia Patrica. Con questo stesso principio si istaurano gemellaggi con le città e i paesi di partenza. Questo ponte culturale serve a non recidere del tutto il cordone ombelicale, a mantenere vivo un pezzo del proprio passato, a lenire il dolore della separazione che spesso è stata non solo fisica con il territorio ma emotiva, personale, familiare: milioni di expat non sono mai più tornati a casa, non hanno mai più riabbracciato i parenti e gli amici, lasciando in eredità ai discendenti quel desiderio atavico di fare ritorno, di non spezzare del tutto il legame antico con le terre di provenienza.
Non è un caso nemmeno, che una volta sbarcati nel nuovo mondo, centinaia di migliaia di ex-italiani abbiano cercato condizioni di vita analoghe a quelle di partenza: gli isolani hanno scelto di vivere sulle coste, i meridionali abituati alla luce e al sole hanno ricercato le stesse condizioni come i piemontesi o gli emiliani i paesaggi collinari. La storia migratoria del centro romagnolo di Meldola che è stato il punto di partenza, fin dall’ultimo decennio dell’Ottocento, di una catena migratoria che ha avuto come destinazione il Connecticut, è in questo senso esemplare: tutta la comunità si è trasferita nella contea di Litchfield, un’area che per molti versi poteva vantare caratteristiche molto simili alle zone collinari e pedemontane del Forlivese. Più o meno con lo stesso principio, gli emigrati hanno portato in Americane le loro competenze “territoriali” ovvero hanno continuato a fare il lavoro tipico di casa propria. Nei primi anni del Novecento le centinaia di migranti partiti dal comune foggiano di Roseto Valfortore, per ricordare il paese d’origine hanno fondato il “borough di Roseto” nella contea di Northampton in Pennsylvania e poi sono andati a lavorare nelle locali cave di ardesia perchè il settore dell’estrazione e della lavorazione della pietra era caratteristico della loro Puglia.
Riuscire anche a livello burocratico a non chiudere i conti ma a tenere vivo il legame con casa, è qualcosa che va ben al di là di un documento. La “fatica”, le carte e le spese legali che solitamente ci sono dietro ad una pratica di cittadinanza dovrebbero scoraggiare, demotivare, disincentivare il riconoscimento. Se questo non avviene ma al contrario ci si batte per veder riconosciute le proprie origini italiane, anche se da anni si vive altrove e probabilmente mai si tornerà mai nella Penisola, è perché la domanda attiene la sfera dei diritti di identità. Volersi vedere riconosciute le proprie origini è appropriarsi di un pezzo della propria storia personale e familiare, e in molti casi è un passaggio fondamentale per sentirsi pienamente se stessi.