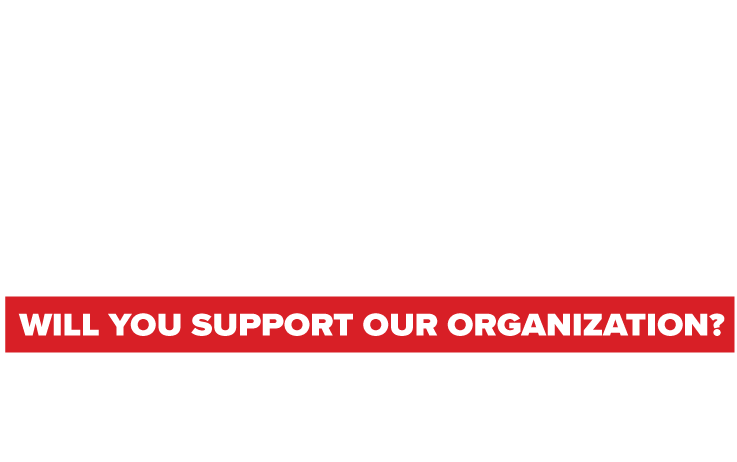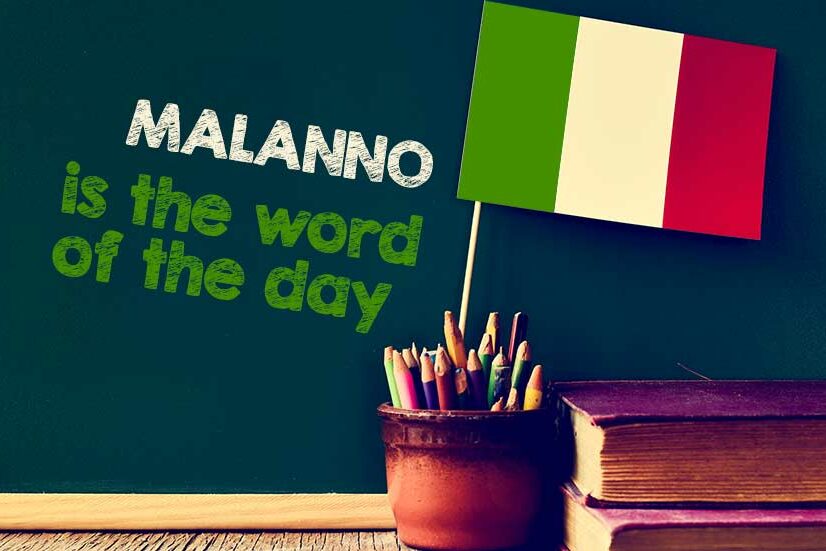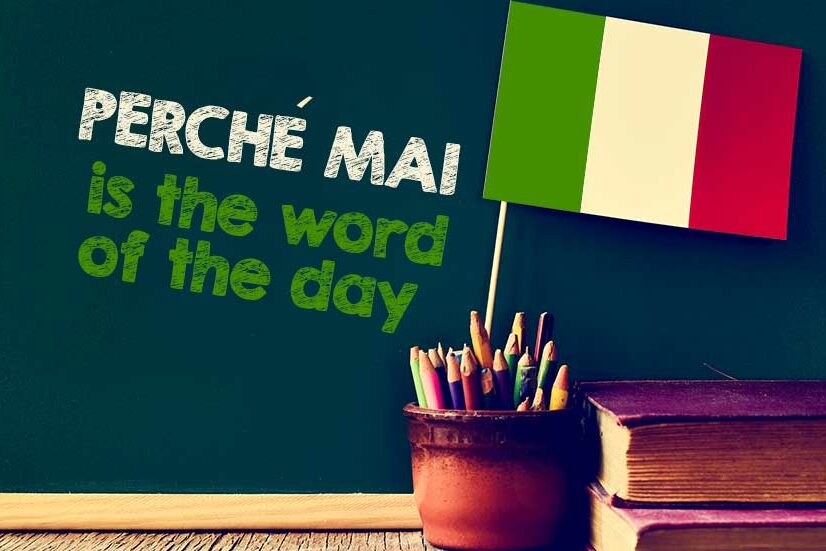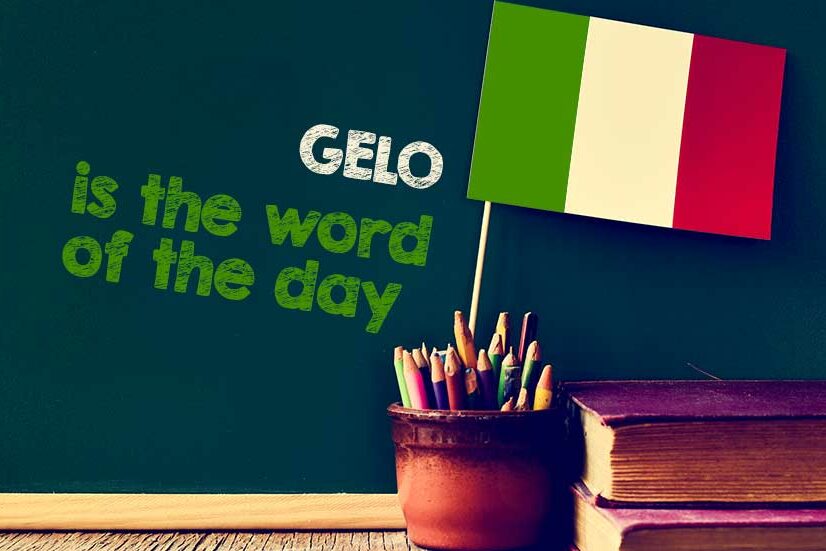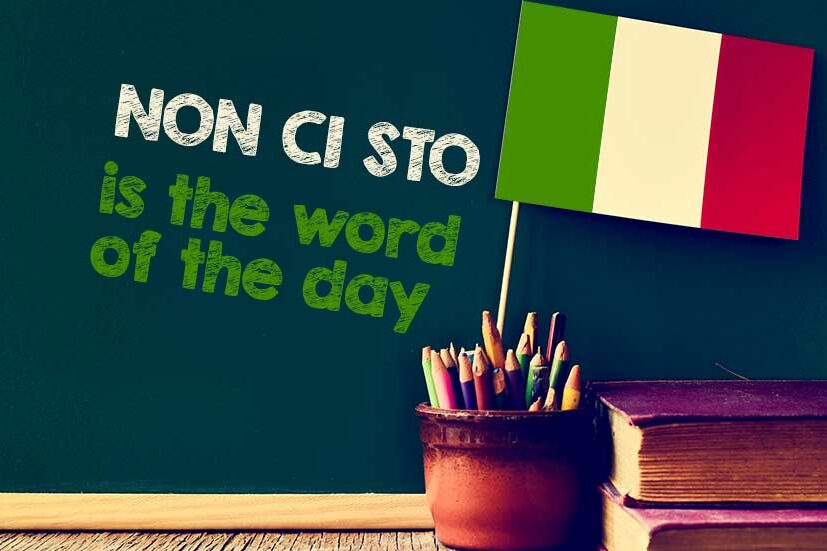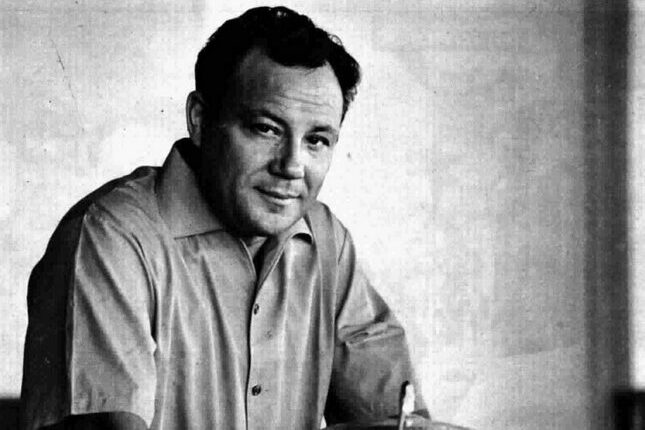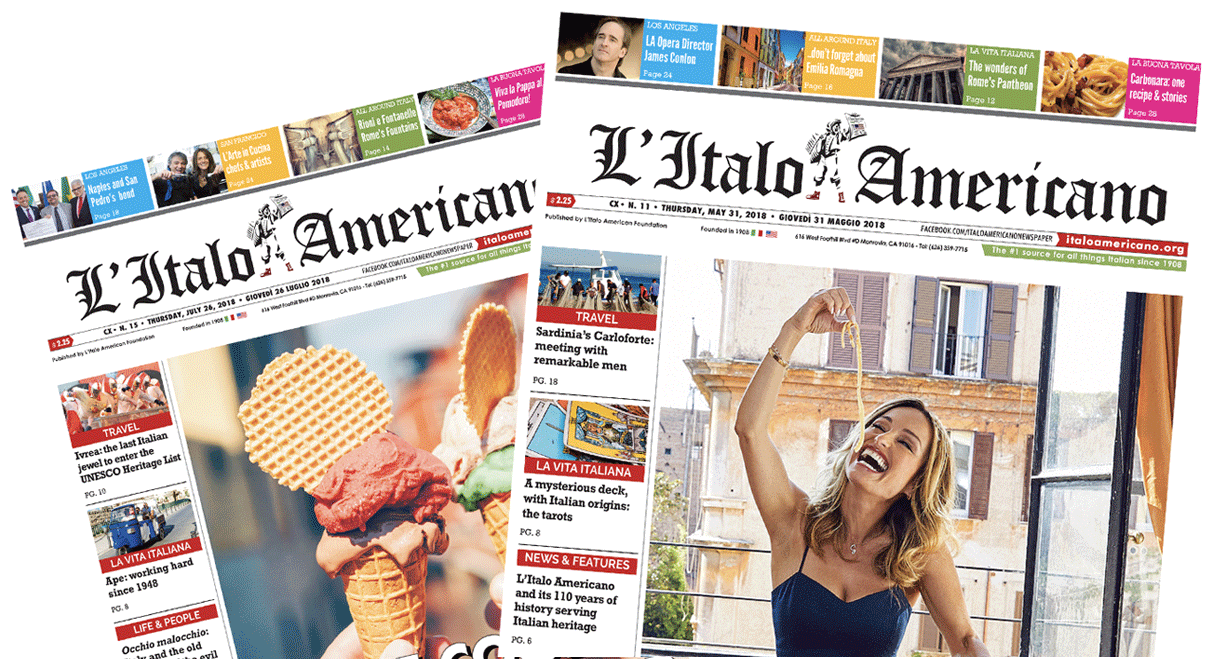“Aggredisce mostri la ragazza di Aquila”, scrisse Eugenio Montale quando gli “Amici della domenica” portarono al Premio Strega, allora agli inizi, una donna che si chiamava Laudomia Bonanni, ma che non sapevano che fosse una donna, per due racconti inediti, poi raccolti sotto il titolo “Il fosso” e “Il Mostro”.
L’anno seguente, nel 1949, Mondadori pubblicò il libro definitivo “Il fosso” con l’aggiunta di altri due racconti, “Messa funebre” e “Seme”.
Montale voleva sottolineare di quei racconti la complessità “tale che uno scrittore dell’Ottocento ne avrebbe tratto romanzi, e la carica aggressiva, la scrittura piena di pungoli”. Così sulla Stampa del 30 giugno 1979 scriveva Giulia Massari. Con “Il bambino di pietra” quell’anno era entrata nella cinquina dello Strega. “Penso che non vincerò – disse – le donne arrivano sempre seconde”. Vinse Primo Levi con “La chiave a stella”.
Lunghi silenzi per scelta, ma anche ingiusti silenzi subiti per anni. “Sono un’abruzzese schiva e selvatica. Quando è cominciata l’industrializzazione della letteratura, mi sono un po’ distaccata dal mondo letterario. Poi mi è tornato il desiderio, il bisogno di pubblicare” diceva di sé.
In questi ultimi anni c’è stata la riscoperta dell’opera bonanniana. Lo si deve all’ Associazione Internazionale di Cultura Laudomia Bonanni, nata per ”la diffusione, la conoscenza e la traduzione delle opere della scrittrice”. Un lodevole lavoro che si è arricchito di ulteriori elementi di conoscenza e valutazione con la pubblicazione di 392 pagine: “Laudomia Bonanni tra memoria e futuro” realizzato da Gianfranco Giustizieri, il più autorevole studioso della scrittrice.
È il suo terzo libro. I due precedenti sono: “Io che ero una donna di domani. In viaggio tra gli scritti di Laudomia Bonanni” e “Laudomia.
Scrittrice senza tempo”. Così Giustizieri sull’ultimo libro: “Ha un titolo che nasconde un dono per la città dell’Aquila: un frammento della sua storia e del suo glorioso passato, per non dimenticare una delle figlie illustri che questo territorio ha generato”.
Una mole di documenti alla base di un volume realizzato con grande scrupolo ed estrema competenza. La cultura della conoscenza. Rilevante il materiale fotografico reperito tra non poche difficoltà. Dalle foto a colori con le copertine di tutti i libri della Bonanni, alle foto in bianco e nero, molte inedite.
Quali criteri ha seguito nella stesura di questo ritratto letterario della Bonanni?
Il libro dispiega, attraverso le sue pagine, la vicenda umana e letteraria di Laudomia Bonanni dai primi anni del ‘900 ai giorni nostri secondo la “narrazione” dei più grandi scrittori e critici letterari. Dall’itinerario complessivo si ricavano due insegnamenti: il valore della memoria e la capacità del suo utilizzo per traguardi culturali e civici dalle radici lontane. Poi, nello specifico, la possibilità di capire come la Bonanni ha saputo leggere i fenomeni sociali del suo tempo, farne letteratura e proiettarli nel futuro con aperture che ancora hanno difficoltà ad imporsi. Fra tutte mi viene alla mente il ruolo della donna nella famiglia e nella società di oggi.
Nel testo ci sono testimonianze autorevoli da Eugenio Montale a Carlo Bo, da Geno Pampaloni a Goffredo Bellonci e anche degli abruzzesi Eraldo Miscia e Giovanni Titta Rosa. Quale immagine viene fuori dai loro scritti su Laudomia?
Una grande scrittrice, una delle maggiori del nostro ‘900 letterario.
Per capire Laudomia e trasmettere il suo pensiero alle generazioni del nuovo Millennio, ha dovuto compiere un lungo percorso culturale mai esplorato finora.
Ho voluto esaminare tutti gli scritti usciti con testi editoriali (non dimentichiamo che c’è una scrittura corposa dispersa in mille rivoli) dal 1927 al 2013 (per l’opera postuma). Ho letto quasi mille recensioni, dai giornali più quotati, ai fogli locali più dispersi. In questa ricerca c’è la scoperta entusiasmante di scritti provenienti da nazioni di cui si ignorava l’esistenza e del coinvolgimento del regista Luciano Paesani che, unico, riuscì a portare sui palcoscenici teatrali un racconto della Bonanni con artisti del calibro di Ludovica Modugno e di Gigi Angelillo.
La migliore conoscenza di Bonanni quanto sarà utile ai giovani di oggi?
Offre preziose opportunità di riflessione. La capacità di andare oltre l’effimero, di approfondire le conoscenze dei mutamenti sociali, di andare oltre le convenzioni radicate nel tempo, di essere ribelli dai giusti occhi, di comprendere i guasti storici di una società reazionaria, di essere sempre e dovunque contro la guerra.
Scavando come un archeologo nel passato sepolto dall’assurdo, lungo e ripetuto oblio, quali sono state le scoperte e le sorprese più belle?
Trovare racconti della Bonanni su lontanissime riviste. Mi riferisco agli anni ’30 e ’40, che ormai fanno parte del mercato dell’antiquariato. Racconti che, a ben leggere, sono gli incipit di futuri romanzi. La rivista “I Diritti della scuola” pubblicò il 29 novembre 1936 il racconto I visi d’Aurora. Nello stesso anno l’Organizzazione Nazionale Balilla di Milano pubblicò il racconto La schiavitù dell’amore. Entrambi costituirono parte integrante del romanzo per ragazzi Men. Avventura al Nuovo Fiore per le edizioni Bompiani nel 1939. Tutti i racconti del libro Città del tabacco (1977) erano già usciti su riviste e quotidiani. Il primo Sezione corrigendi che nel libro porta il titolo Porte chiuse era uscito nel 1940 e così per molti altri libri. Racconti “rari” li troviamo nella rivista Costellazioni, pubblicata a Milano negli anni ’40 e ’50; su “L’approdo letterario” dell’Eri negli anni ’60; sempre negli anni ’60 sulla rivista enogastronomica Romani a tavola diretta da Luigi Volpicelli.
Non sono mancate le stroncature e lei con molta onestà intellettuale le ha riportate nel libro destinato ad avere un ruolo fondamentale nella comprensione del mondo di Laudomia. Quali sono stati i critici più cattivi?
Ne ricordo soprattutto due che emergono per un’acredine di fondo. La prima, in occasione del premio opera prima Bagutta per “Il fosso”, con lo pseudonimo Giulia Sofia su L’Europeo di Milano del 26 febbraio 1950 scrisse: “…non ho capito perché hanno premiato un’opera pubblica importante per la malaria”. L’’altra di Sergio Saviane, che su Cronache di Roma il 7 dicembre 1954, a proposito di “Palma e sorelle”, sentenziò: “Con tutto il rispetto che abbiamo per l’editore Casini è difficile, credo, perdonargli di aver pubblicato un tal mucchio di parole e parentesi, che rischiano di diventare, oltre che inutili e ridicole, addirittura nocive”. Bisogna ammettere che molte osservazioni venute da critici famosi non sono da sottovalutare: provincialismo diffuso nelle prime opere (Emilio Cecchi), impianti romanzeschi freudiani nelle ultime (Claudio Marabini).
E Laudomia come reagì?
Sdegno assoluto in alcune lettere agli amici nel caso degli “assalti” personalistici, serenità con i critici intelligenti, cessazione di ogni forma di scrittura quando nel 1982 capì il mutamento di gusti e le difficoltà poste dal suo editore Bompiani.
In conclusione, qual è la più grande lezione che ci viene da Laudomia dopo aver letto questo libro?
Una scrittrice che non si adeguò mai alle mode letterarie, anticipò molte e importanti tematiche sociali, usò la penna come un sasso.